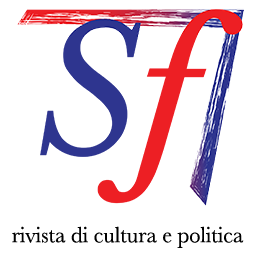«Lo sapete chi è che sòna? […] È Paolina Borghese, ’a sorella de Napoleone… Sì ma ’n penzate a’a statua de Canova, quella ’gnuda sur materazzo de marmo. Vedeste com’è ridotta… pelle e ossa. Sta sempre rintanata là ddentro co’ la madre, Madama Letizzia. Du’ vecchiacce, du’ gufi, sempre a spia’ da dietro ’e perziane er vicinato, a spettegola’. Che decadenza… Certo che la vita è ’no sfacelo. Io quanno penzo a la vita me moro de paura».
A parlare è Giuditta Di Castro, popolana del ghetto cui una Claudia Cardinale nel fiore degli anni presta il corpo – non la voce, che è della romana Rita Savagnone. Siamo ai tempi di papa Leone XII, nella Roma della Restaurazione ricostruita da Luigi Magni a fine anni Sessanta[1]. Giuditta sta parlando col giovane carbonaro Angelo Targhini nel pieno di un’ansiogena serata fatta di trame, agguati e guardie papaline. Pure nella tensione del pericolo, i due rallentano e poi si fermano ai piedi della fontana di piazza Mattei ad ascoltare il metallico clavicembalo che regala la sua melodia triste da una finestra lì vicino.
Gli occhioni da cerbiatta della Cardinale mi sembrano guardare verso palazzo Costaguti, a un angolo della piazza. Indago e scartabello. Non risulta che i Borghese siano mai stati proprietari del palazzo. Qui s’insediò una famiglia di banchieri genovesi nel tardo Cinquecento e il nome del casato fa ancora bella mostra di sé sull’architrave del portone principale. Allora? Lavora di fantasia, mi esorto. Non faceva mica lo storico, Magni. Girava film storici, che è tutta un’altra cosa. Mi rendo conto che la deformazione professionale inizia a giocarmi brutti scherzi. E quella che riconosco inconfondibilmente come piazza Mattei può diventare qualunque altra cosa dietro la quarta parete del cinema. Perfino una piazza Venezia ancien régime.
C’era una volta il papa re. A quei tempi, piazza Venezia non era ancora il sancta sanctorum della religione patria, il grande palcoscenico della Nazione. L’affastellamento dei secoli aveva modellato un’arena approssimativamente rettangolare, allungata, dominata da composti edifici nobiliari. Nei decenni in cui il colosso di marmo botticino scalava le pendici del Campidoglio e protendeva il gigantesco, candido corpaccione tutt’attorno reclamando spazio, molti antichi abitanti sparirono dalla ribalta, mentre i pochi superstiti si salvarono più che altro per la fortunata posizione urbanistica rispetto alla marea inesorabilmente incombente di scalinate, colonne, statue, balaustre, fontane.
Tra i sopravvissuti vi fu palazzo Bonaparte, bastione mancino di via del Corso e parte integrante della quinta venutasi a creare, sorta di enorme zona di rispetto, davanti al supremo monumento regio. Nel 1818, quando Vittorio Emanuele II non era neanche nato, Maria Letizia Ramolino, la madre di Napoleone e Paolina, comprò la dimora fatta costruire dai D’Aste nel Seicento. Ci visse quasi vent’anni da esule, benevolmente accolta dallo Stato pontificio, al centro della comunità locale dei napoleonidi, fantasma ieratico delle estinte glorie di famiglia. A pochi mesi dalla fine, così la vedeva il Belli, crudele e preveggente:
Sta ssopr’a un canapè, ppovera vecchia,
impresciuttita llì peggio d’un osso;
e ha ppiù ccarne sto gatto in d’un’orecchia
che ttutta quella che llei porta addosso
[…]
Cala oggni ggiorno e vva sfumanno a occhio.
Semo all’Ammèn-gesù: ssemo a lo sgommero:
semo all’ùrtimo conto cor facocchio[2].
Palazzo Bonaparte è oggi uno spazio espositivo privato aperto al pubblico[3]. Il giorno dell’inaugurazione gironzolo per le sale ormai svuotate d’arredi e suppellettili, e finisco nei panni di Madame Mère. Il suo balconcino prediletto, il mignano di legno dipinto in cui si celava a scrutare il via vai giù in strada, è preda dei visitatori. Facciamo la fila per introdurci nell’angusta galleria, ad angolo retto tra la piazza e via del Corso. Eccole le «perziane» di cui parla Giuditta. Di clavicembali nemmeno l’ombra. Anche se fosse, non se ne apprezzerebbero le note con l’incessante brusio che sale dal traffico.
Nei suoi anni romani, Paolina in realtà non abitò da sua madre, né in una delle tante proprietà del secondo marito, quel principe Camillo Borghese con cui l’idillio non sbocciò mai. Nel 1816 si comprò una villa con giardino adiacente alle Mura aureliane, fatta costruire a metà Settecento da un alto presule e sofisticato mecenate[4]. Nota come villa Paolina (o Bonaparte), dal 1950 ospita l’ambasciata francese presso la Santa Sede. Tanto per cambiare. A Roma, prima o poi, si finisce sempre a ragionare di ambasciate.
Belli e impossibili, i siti diplomatici si ammirano da lontano. Saranno pure impeccabili manutentori, ma si contano sulle dita di una mano i paesi che concedono accesso all’interno delle rispettive enclavi. Alcuni schiudono le porte in circostanze eccezionali. Penso all’ambasciata tedesca presso la Santa Sede, un gioiellino di sobrio buon gusto venuto negli anni Ottanta dalle bigie terre teutoniche a impreziosire la ridente Valle Giulia. Era nel programma dell’ultimo «Open House Roma», il paradiso dei cacciatori d’architetture urbane. L’idea è piaciuta tanto agli assatanati aficionados della manifestazione che cinque minuti e tutti i turni di visita erano completi. Lo so perché m’hanno fregato sul tempo.
Ma a consolarci ci pensano i Francesi. Due ambasciate? Tutt’e due visitabili. Bravo!
Chi tra i lettori di «Suite française» non ha un amico transalpino che l’ha invitato a un ricevimento del 14 luglio, a una visita per pochi intimi nella galerie des Carraches, o anche solo a un pomeriggio di studio e chiacchiere nella biblioteca dell’École française? Se c’è un pezzetto di Francia a Roma che sia noto ai più, quello è palazzo Farnese. Coi suoi sedili di pietra, i militi e le transenne, il finestrone centrale che inquadra gli affreschi visibili dalla piazza, l’impavido cornicione michelangiolesco che fa l’equilibrista a decine di metri d’altezza.
Ad aprire le porte sia del «dado dei Farnese» sia della discreta, pressoché invisibile, villa Paolina è un’associazione dal nome evocativo: Inventer Rome. Inventare, recita il «Larousse». Ma anche invenire. Cioè cercare e trovare, scovando l’insospettato. Non chiedo di meglio.
È un bel pomeriggio d’inizio estate quando, al seguito della nostra guida, varco la frontiera assieme a un manipolo di dénicheurs. Non dall’entrata originaria, cioè dall’attuale via XX Settembre, bensì dalla parte opposta. La modifica, prettamente funzionale, fu introdotta proprio dai Tedeschi, che qui ebbero per qualche tempo la loro ambasciata presso la Santa Sede prima dell’arrivo dei Francesi. I quali dovettero apprezzare il nuovo assetto. In un colpo solo, infatti, scansavano due simboli ostili.
Il primo nella toponomastica. Quel fatidico giorno del 1870 che ricorda lo smacco subito dal pontefice e da Parigi, sua protettrice, quando i militi savoiardi entrarono di qui a conquistare la città santa, prossima capitale del neonato Regno d’Italia. Il secondo nell’architettura. È l’ambasciata del Regno Unito, palafitta brutalista piantata negli anni Sessanta a colmare la voragine lasciata dagli ordigni sionisti dell’Irgun nel 1946. Carcerieri di Napoleone a Sant’Elena, i Britannici decretarono la fine di un’epopea politica e, per Paolina, l’inglorioso epilogo del vincolo che la legava all’amatissimo fratello.
L’accesso odierno di villa Paolina dà su via Piave. Pur sempre reminiscenza bellica ma almeno scevra da qualunque misogallismo. Il verde del piccolo parco è sontuoso e impeccabile, chiuso su un lato dalla faccia interna delle mura imperiali. È qui che i bersaglieri aprirono la breccia detta di Porta Pia. L’edificio padronale è fresco di restauro[5]. Luccica di nitore neoclassico e stile Impero, di qualche pregiato tocco di Balthus, di mobilio d’altissimo rango e dell’algida eleganza di dove si officiano gli ovattati cerimoniali delle relazioni internazionali. Dei tempi di Paolina resta la memoria in spazi oggi riconvertiti, come la biblioteca pensata per esaltare la figura della donna intellettuale; in varie decorazioni: quella della stanza egizia, per esempio, a ricordo delle imprese africane del fratello; nell’oggettistica minuta e meno minuta – è il caso di una vasca alla romana, oggi nel giardino, in cui la padrona di casa, paladina dell’igiene personale, soleva lavarsi con latte asinino o forse vaccino.
Mi concedo un’escursione al Museo Napoleonico, sul lungotevere, a caccia di qualche reperto trasferito qui dalla dimora di Porta Pia. Nella saletta dedicata alla principessa Borghese in questo sacrario delle memorie bonapartiste, acquerelli ottocenteschi della villa costellano i muri alternandosi a cimeli intimi della diva: dai mouchoirs di batista al taccuino in marocchino rosso, passando per le ciabattine da camera ricamate in oro che accolsero i celebrati piedini. In una teca spunta il calco in gesso del seno destro, traccia del maniacale (feticistico?) mimetismo che Antonio Canova impiegò per ritrarla nella posa scultorea della dea.
Già, la statua di Paolina alla Galleria Borghese. Così iconica, vi confesso, da togliermi ogni curiosità. C’è un altro posto, per la verità, dove conto di portarvi. Chissà se indovinate. Vi do un aiutino.
«Le luci della grande città mi hanno sempre ubriacato la mente. Vorrei andare in Santa Maria… Roma è fredda stasera»[6]. Le parole di una vecchia canzone di Venditti, «Dove», calzano a pennello mentre scrivo queste righe in una gelida nottata d’inizio dicembre. Che Madonna aveva in mente Antonello? A cerca’ Maria pe’ Roma, lo sappiamo, si perde solo tempo. Ma se proviamo insieme magari ci divertiamo.
Tanto per cominciare, è Nova o Antiqua ’sta Maria? Credetemi, non ne faccio una questione di Cosmedin, anche se l’occhio vuole la sua parte, ma soprattutto di carisma. E poi dov’è che bazzica? Un giro in Via, dall’Aracœli a Campo Marzio passando per Campitelli? O fa lo struscio tra il Popolo e via Lata, pardon via del Corso? Una camminata Liberatrice oltre il fiume fino a Traspontina, al limite a Trastevere? O sarà su da Minerva per un burraco a cinque con Egiziaca, Carmine e Maddalena?
Ma magari non è in città, chissà: campagna, montagna, mare… hai voglia a cercare. Un pic-nic (prodotti dell’Orto rigorosamente km 0!) in un’amena Vallicella dalle parti di Galeria, al fresco d’una Quercia o di un Celsano?[7] Un po’ di sano trekking, senza strafare, tra Monti e Monticelli, in cerca di un eremo o una Grotta Pinta su per il Monserrato, il Monterone, meglio ancora il Montesanto? E se avesse noleggiato quella Navicella a remi che diceva per farsi un tour al Porto della Salute?
O ancora, perché no, potrebbe aver ceduto al fascino archeoindustriale di quelle vecchie Fornaci fuori Porta (Paradisi laggiù) – roba da Trivio, penserete voi, ma piena di Grazie, dico io? A Loreto in ritiro o in borghese, non sia mai, per una serata alla Scala?
Dovunque sia, mi chiedo se avrà mai tempo per una Visitazione e quattro chiacchiere, giusto qualche Annunciazione gossip. Domnica inclusa, pare sia spesso in Cappella a far Miracoli, Ausiliatrice e Consolatrice di gente dall’Anima afflitta, il Rosario in mano e tanto bisogno di un Buon Consiglio. Oberata da Orazione e Morte, da Pianto e Sette Dolori, immagino che in foro interno non abbia Pace né veda Luce. Non sembra crucciarsene, d’altronde, e segue con successo la sua Concezione di vita.
Una Vittoria dell’Umiltà, apparentemente. O un modo come un altro, insinuano le malelingue, per apparire In Publicolis un’irresistibile Regina dei Cuori. D’altronde, che si sia Mediatrice o seduttrice – Paolina insegna – quel che conta è farsi un buon Nome e godere di largo Suffragio. Possibilmente universale.
Sballottato tra amor sacro e amor profano, fugo gli interrogativi vostri, e ormai pure un po’ miei, obbedendo alle ragioni della gerarchia. Se Santa Maria dev’essere, che Maggiore sia!
All’ingresso, m’imbatto nell’immancabile orpello securitario che ormai filtra l’accesso alle basiliche papali. Mentre aspetto il mio turno, mi sovviene che il metal detector servì a ben poco due anni fa, quando fu facilmente eluso da un senzatetto armato di un vetro tagliente per un raid anticlericale. Disarmato e fiducioso, supero i controlli al check-point e assaporo gli attimi prima dell’impatto con la sublime sinfonia dell’estetica cattolica.
Non conosco interno basilicale più armoniosamente diacronico di questo. Dal paleocristiano al XXI secolo, è come se stuoli di architetti, pittori, scultori, mosaicisti, marmorari, stuccatori, intagliatori, ebanisti, scalpellini si fossero perfettamente accordati al termine di un briefing lungo quanto la vita del cristianesimo per plasmare un oggetto che sembra il prodotto di un’unica eccelsa (e terrena) mente coordinatrice. Secoli di buon gusto lentamente sedimentati in una concrezione equilibratissima, manifesto del dialogo tra le generazioni.
Percorro lemme lemme la navata sinistra, in direzione di quella cappella Paolina che sembra voler omaggiare la nostra eroina ed è invece un lascito di papa Paolo V Borghese. In compenso, della nostra ospita le spoglie mortali.
Fu lei a voler riposare qui per significare al marito, in extremis, quell’affetto remissivo che solo la malattia, rubandole il senso d’onnipotenza, le aveva risvegliato. Le si attaglierebbe perfettamente come dimora post mortem questa chiesa nella chiesa, esuberante congegno barocco pieno di colori, personaggi, opulenza. Eppure c’è di tutto in questo trionfo dell’horror vacui, tranne lapidi bonapartiste.
Temporeggio ancora a rimirar marmi e poi mi decido per l’artigianalità terra terra: vado a chiedere in sacrestia. Qui mi accolgono due frati francescani nel saio grigio-azzurro dell’Immacolata, lo sguardo tediato. Di Paolina a Santa Maria Maggiore il primo non ne sa nulla, e va di smartphone in cerca di notizie. L’altro ipotizza che sia lì dove dico. Ma non nella cappella, bensì nella cripta sottostante. «Nemmeno io l’ho mai vista», la chiude lì laconico.
Fonti più accurate mi diranno che il frate non sbagliava. Paolina riposa in un umile sepolcro nel piccolo cimitero sotterraneo dei Borghese. Entrarci è praticamente impossibile. È proprietà di famiglia. Quindi non sarà su un foscoliano sepolcro il saluto di commiato. Pazienza, mi dico. Ci sono intoppi sulla via del flâneur da cui c’è solo da imparare. La Galleria Borghese, già vittima della mia hybris, torna a reclamare i suoi diritti. E a ragion veduta.
A tutto c’è rimedio fuorché alla morte, sentenzia il popolino. Ma a saperci fare, un modo si escogita per restare diversamente vivi. Paolina in questo fu precoce e privilegiata maestra, ed è giusto rendergliene atto. Mi recherò dunque contrito sul simulacro della sua gloria mondana. Con scuse e omaggi alle grazie di cui ci onora immota nel suo marmoreo, pigro narcisismo, aristocratica Bocca di rosa circondata da un pubblico senza tempo né confini.
[1] «Nell’anno del Signore», 1969.
[2] Giuseppe Gioachino Belli, «Madama Lettizzia», 8 settembre 1835.
[3] M.E. Tittoni et al., Palazzo Bonaparte a Roma, Roma, Editalia, 1981.
[4] M.G. Sordi, Villa Paolina a Roma, in R. Morselli, R. Vodret (a cura di), Ritratto di una collezione. Pannini e la Galleria del Cardinale Silvio Valenti Gonzaga, Milano, Skira, 2005, pp. 113-117.
[5] Villa Bonaparte. Résultats et révélations des dernières restaurations, Roma, De Luca, 2019. Un excursus storico è in Villa Bonaparte. Ambassade de France près le Saint Siège, Paris, Éd. du patrimoine, 2011.
[6] Antonello Venditti, «Dove», in L’orso bruno, 1973.
[7] Così chiamano il gelso in quelle lande agresti.