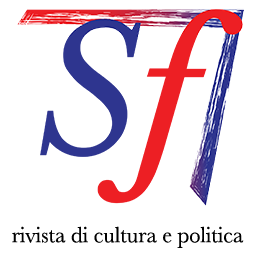«TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM. TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORVM». Ci vuole un po’ per leggere tutta l’iscrizione girando su sé stessi col naso all’insù, lo sguardo aggrappato alle tesserine del mosaico che riveste internamente il tamburo del Cupolone. Se bastò una pietra a reggere il colossale impianto della Chiesa universale, ci volle ancor meno a sostenere per secoli il patto che ha tenuto avvinte la Francia e la Roma cristiana. Fu sufficiente una pietruzza. Petronilla, appunto. La figlia di Pietro. Così dicono.
Il mio viaggio sulle tracce di questa vedette della geopolitica cattolica inizia nella basilica vaticana perché è qui che giace il suo corpo dentro un altare barocco, dietro uno dei quattro giganteschi pilastri che reggono l’immensa calotta. Peccato che esplorazione e rito raramente collimino. L’altare è sul versante ovest del transetto nord, in un’area inaccessibile ai visitatori privi di lasciapassare o di finalità rigorosamente confessionali.
Hai voglia a negoziare con l’addetto della Reverenda Fabrica piazzato lì apposta per filtrare il passaggio. Non c’è niente da fare: o miri a nettarti l’anima o sei equipaggiato d’autorizzazione dei burocrati. Peccato (!) che abbia dichiarato le mie laicissime intenzioni investigative, sennò avrei potuto rinverdire arrugginite pratiche penitenziali – flâner varrebbe bene qualche padrenostro e avemaria, ne converrete. Quanto ad amministrazione d’Oltretevere sono decisamente un neofita e non ho tempo né voglia di girare per uffici. Per adesso mi arrendo e torno sui miei passi.
Mi consolo ricalibrando la mia agenda. Lasciamo che la cronologia prenda il comando, mi dico. In fondo, una divagazione romana attraverso il culto di una protomartire non può che iniziare là dove tutto iniziò. Dove il cristianesimo, infiltrandosi nelle viscere dell’Urbe, costruiva la sua capitale in negativo. Sopra, in centro, splendeva la luce della metropoli di marmo, issata mattone su mattone, colonna dopo colonna; sotto, in periferia, si rincantucciava umile la favela di tufo, scavata galleria sotto galleria, loculo accanto a loculo. Si va per catacombe, dunque. Si va nel parco dell’Appia antica.
Toglietemi fontane, piazze, chiese, palazzi. Toglietemi tutto, se vi pare. Ma non toglietemi il parco dell’Appia antica, mirabile miscuglio di antico, tardoantico, falsoantico e postindustriale, dentro le mura fuori le mura, verde, rovine, placide greggi. Nel parco dell’Appia antica succedono miracoli.
I sampietrini che altrove si dispongono a mo’ di montagne russe tendendo tranelli all’ignaro scooterista qui s’irreggimentano disciplinatissimi, un esercito compatto di leucitite a dominare sicuro giù fino alle terre dell’anarchico basolato. Pavimentazione liscia, traffico scarso, zero autovelox e praticamente nessun semaforo: una perfetta autostrada urbana per sfogare istinti da Formula 1.
E invece il romano medio, che sfreccia attorno a Colosseo e Castel Sant’Angelo come fossero fastidiosi spartitraffico, sull’Appia antica, altro miracolo, procede alla velocità d’uno chauffeur della Belle Époque. Sarà che l’Appia antica non porta a un monumento, è il monumento. Anche l’ultimo dei cafoni sa che non si calpesta il manto di una regina e, se proprio capita, si fa col massimo della cortese deferenza, e con mille scuse.
Nel parco dell’Appia antica si parcheggia. Reggetevi forte… dentro le strisce! Se non è un miracolo questo. Andate a visitar catacombe e ne avrete la prova. D’altronde un motivo c’è se le catacombe di Roma (e i relativi parcheggi) sono vuote. Gli appassionati del genere sono tutti in fila a Parigi per vedere quelle, tarocche, di place Denfert-Rochereau. Miracolo, questo davvero sommo e imperscrutabile, del marketing turistico.
In sella al mio fido motorino, imbocco l’Ardeatina e poi svolto su Via delle Sette Chiese. È il segmento suburbano dell’antico percorso pio alle cui sorti diede lustro San Filippo Neri per rinvigorire un impeto devozionale indebolito dai feroci strali dei Riformati. Questo tratto collegava San Paolo e San Sebastiano. In mezzo, il cœmeterium Domitillæ. Sono quasi arrivato, ma Domitilla ha voglia di celie.
Mi appare da destra a lettere cubitali bianche sul bruno di un muraglione con cancello chiuso. Avrò sbagliato giorno? Inversione a U poco più avanti, torno indietro e spunta dall’altro lato della via. Giunto all’interno, la buontempona non ha nessuna voglia di presentarsi una volta per tutte. Gioca con le identità. Si sdoppia. È convertita, sì, ma al giudaismo o al cristianesimo? È una santa o solo una brava donna? Poco importa, non è lei la star del posto. L’architrave all’ingresso dei sotterranei mi dice che sono sulla buona strada: Basilica S. Petronillæ, sentenzia.
Due rampe di scale e mi si schiude l’incanto di un’aula ipogea di fine IV secolo. Anche quando sono protette come questa da un robusto restauro ricostruttivo, le architetture paleocristiane sembrano sempre preziosamente fragili. E poi ce ne sono talmente poche, e poco celebrate, che mi danno l’assurda sensazione di essere più antiche del classico, più bisognose di cura. Mi muovo circospetto come su un tappeto d’uova.
La nostra guida, timidissima e un po’ sbrigativa, non ha voglia di essere registrata per ragioni di privacy, ma in compenso mi porta subito a quel che m’interessa. Dietro l’abside della basilica si nasconde un cubicolo di pochi metri quadri, visibile solo dalla transenna all’ingresso. Di fronte a noi, un affresco mutilo incastonato nella lunetta di un arcosolio. Mostra due donne su fondo bianco ritratte con l’essenziale levità che hanno le pitture cristiane dei primordi.
A sinistra, in primo piano, la matrona Veneranda: alta; lo sguardo lontano, malinconico, senza dolore; le braccia larghe in posa d’orante, nella serena accettazione del decesso. La veste una sorta di dalmatica, un velo a mo’ di turbante le cinge il capo; accanto a lei, i fiori del giardino celeste. Un libro aperto svolazza a mezz’altezza a significare il vangelo e, quindi, la fede della defunta. Le sta al fianco, seminascosta, colei che cercavo, abbigliata con una tunica. «PETRONELLA MART(YR)» recita la didascalia rossa che le danza attorno alla testa scoperta. Il braccio destro sta dietro la schiena di Veneranda, ad accoglierla con delicatezza nell’aldilà. In basso si vede un contenitore circolare colmo di volumi, simbolo delle sacre scritture, verso cui la mano sinistra della “donzella” sembra dirigersi[1].
Letteratura agiografica e successo cultuale a parte, quest’affresco è la sola prova che una Petronilla martire e santa sia storicamente esistita nel I secolo. Per essere la sua unica comparsata, la nostra fa un figurone quanto a tatto, empatia e grazia. Dev’esser stato quest’innata compostezza a ispirare racconti della sua vita in cui la santità non è frutto di martirio violento bensì di un’irresistibile vocazione virginale, una sorta di martirio soft. Pretesa in sposa da un nobile pagano, tale Flacco, ottenne tre giorni di tempo per pensarci su pur sapendo benissimo dove andare a parare. Ne approfittò, infatti, per digiunare e pregare. E alla scadenza dei tre giorni, ricevuta la comunione, «mandò fuori lo spirito»[2]. Cioè morì.
Nulla a che vedere con gli orribili trapassi copiosamente raffigurati in certe chiese romane, dove, con gusto splatter ante litteram, si vede gente segata in due, decapitata, data in pasto a belve feroci, bollita o grigliata, tra pozze e zampilli del proprio stesso sangue. Certo l’aver molto sofferto aveva i suoi vantaggi. Proprio per la scarsa truculenza della sua dipartita Petronilla fu, infatti, declassata a vantaggio dei soldati convertiti Nereo e Achilleo, loro sì crudelmente e lungamente torturati. Fu in corrispondenza della loro tomba che papa Siricio fece costruire l’altare basilicale nella catacomba in cui mi trovo. E pensare che era stato l’Onnipotente in persona (si fa per dire) a risparmiare a Petronilla la brutta fine promessale da Flacco in caso di rifiuto, ritenendo di farle un favore. Magari toccava spiegare a Siricio che «multa sunt martyria, quæ sunt sine sanguine fuso»[3].
Martire incruenta o vergine che fosse, o tutt’e due, Petronilla ebbe presto un successo indiscusso. Cosa aspettarsi, d’altronde, da una che assommava i lignaggi gentilizi degli Aureli e dei Flavi, e il cui soprannome, quello che i Romani chiamavano cognomen, suggeriva un vincolo strettissimo nientemeno che col primo papa? In realtà, ci spiegano i ben informati, Petronilla non era così detta per via di quel Petrus che tutti conosciamo bensì di un più modesto, cristianamente parlando, Petronius. Se la seriosa scienza ha smorzato i toni lirici della credenza, resta l’ipotesi che la figliolanza in questione fosse non già carnale bensì spirituale. Come che sia, la notizia dell’illustre parentela prosperò nei secoli elevando Petronilla alle altissime sfere della gerarchia devozionale. Prole del prediletto del Salvatore.
Quando riemergo alla luce naturale, i trenta gradi di una sonnacchiosa domenica di luglio ripristinano in una manciata di secondi l’equilibrio termico sconquassato dall’umido freddo ctonio. Ci vuol poco per desiderare qualcosa di fresco e ancor meno per trovare quella che gli internauti premiano come la migliore gelateria di zona. Risalgo in sella, due minuti e sono a Tor Marancia. È una borgata costruita nel Ventennio[4], con tale dispendio di risorse e ingegno da meritare il nomignolo di Shanghai per via dei continui allagamenti che le davano l’aspetto di una risaia. Fu solo nel dopoguerra, con la costruzione delle palazzine attuali e l’ammodernamento delle infrastrutture, che Tor Marancia si avviò al dignitoso benessere con cui si presenta oggi agli occhi del passante.
Rinfrancato da una coppetta che conferma i dicitur della Grande Rete, gironzolo per le strade semivuote e m’imbatto nel mio destino di giornata. Via di Santa Petronilla mi si annuncia quieta e silenziosa, come si addice all’eponima. Intrisa di devota humilitas, non azzarda una targa in marmo di Carrara ma si accontenta di uno di quei cartelli metallici col contorno blu dai bordi arrotondati, che popolano le strade dello Stivale dalla fine del Novecento. E poi mi mostra discretamente il suo volto. È una “donzella” di bell’aspetto, età puberale o poco più, le guance paffute e gli occhi tristi, maturi. Ricorda vagamente la ragazza afghana fotografata da Steve McCurry. M’insospettisce l’abito, che ha drappeggi di una veste senza tempo ma anche qualche cenno decorativo meno arcaico. Sarà davvero la mia lei?
Se voglio saperne di più, certo devo chiedere altrove. I murales solitamente non parlano e quelli del museo condominiale di Tor Marancia non fanno eccezione[5]. Ratta navigazione e scopro che sto diventando ossessivamente monotematico. La ragazzina che mi osserva, mesta ma fiera, fu fotografata da Francesco Paolo Michetti nel 1891 in occasione di un venerdì santo nell’Abruzzo rurale[6]. Guido van Helten, writer australiano avvezzo alla ritrattistica iperrealista, ha riprodotto la foto immaginando nella protagonista un’abitante del neonato miserando quartiere. L’opera s’intitola “Io sarò”. Cara ragazzina, cosa sarai lo ignoro. Fosti un’infante campagnola fin de siècle, questo so, e sei diventata una borgatara anni Trenta. Non ti spiacerà, spero, rimanere per qualche attimo ancora la mia Petronilla.
Mi reimmergo definitivamente nel regno dei vivi e dell’asfalto. Svicolando e sobbalzando tra una buca schivata e un’altra centrata in pieno, rimugino. Se il patriarcato di Roma vinse la sua sfida contro i rivali orientali per la primazia nel mondo cristiano, fu in gran parte grazie al culto dei martiri e delle reliquie che materializzavano il sacrificio dei campioni della fede. La morte corporea dei testimoni rinnovava l’immolazione di Cristo e regalava la vita autentica, quella eterna. Il vero credo vinceva sulle fole pagane nella città in cui queste avevano trionfato e avevano illuso i propri fedeli di poter sconfiggere la religione giunta dall’est. Si preparava invece, attraverso le persecuzioni, un nuovo, inedito impero. Chi avesse voluto farne parte sarebbe entrato in contatto con i frammenti di un’insanguinata memoria.
Lo sapevano bene i cristiani delle origini, che facevano a gara per avere la tomba vicino a quella dei martiri. La nostra Veneranda la gara la vinse, perché il suo sarcofago era vicinissimo a quello della protettrice. Che però nel frattempo si è dileguata. Per smuovere il corpo di un martire dal sito originario della sepoltura ci voleva un motivo serio. Il deperimento materiale del sepolcro o dell’architettura tutt’attorno, per esempio, o il rischio di saccheggi da parte d’invasori. O ancora, l’inadeguatezza del luogo ad accogliere i pellegrini. O magari un debito di riconoscenza nei confronti di un re.
Per secoli il sarcofago marmoreo di Petronilla giacque qui, solcato da un’iscrizione che recitava, tra l’altro, «PETRONILLÆ FILIÆ DULCISSIMÆ». Abbastanza perché la credulità altomedievale l’attribuisse alla mano stessa dell’apostolo Pietro. Nell’VIII secolo i Longobardi minacciavano l’incolumità dell’Urbe, arrivando a devastarne i dintorni. In cerca di un difensore, i papi si rivolsero ai Franchi. Il loro sovrano, Pipino il Breve, ridusse a mal partito i minacciosi nemici del pontefice e promise la donazione delle terre italiane che erano state bizantine. Ebbe in cambio un’auxiliatrix.
Come il re dei Franchi era ormai protettore di Roma e figlio della Chiesa, così Petronilla, figlia di Pietro e quindi della Chiesa stessa, era destinata a diventare a sua volta protettrice della Francia e garante del patto tra papi e re d’oltralpe. Non ne abbiamo la certezza, ma dev’esser stato questo il ragionamento che indusse alla traslazione del sarcofago di Petronilla dalla sua oscura catacomba alla solenne basilica costruita sulla sepoltura di Pietro. Dapprima fu Stefano II a promettere il trasferimento, ma morì prima di poter fare alcunché. Poi fu il turno del suo successore, e fratello, Paolo I.
Siamo nel 757 e la basilica vaticana è ancora quella fatta costruire qualche secolo prima da Costantino. Sul lato sud dell’edificio, sorgeva una costruzione cilindrica detta per antonomasia “il mausoleo” giacché, di fatto, era la cappella cimiteriale fatta edificare dall’imperatore Onorio per sé e la sua famiglia[7]. Fu qui che trovò posto il corpo della nostra. E fu da allora che la rotonda vaticana, debitamente restaurata e ridecorata, fu detta cappella di Santa Petronilla, chiesa Franca nella città santa. Quando Carlo Magno fu eletto imperatore proprio in San Pietro, Petronilla toccava l’apice del suo potere simbolico. Era la notte di Natale, A.D. 800.
Trascorsero oltre seicento anni. Da un pezzo l’impero latino non parlava più la lingua romanza dei Franchi ma quella aspra e un po’ barbarica in uso a oriente del Reno. La basilica sul colle Vaticano, venerabile cimelio, era corrosa dal male incurabile del tempo che passa. Sul suo sacrificio si sarebbe presto consumato il rito di rinascita della Chiesa di Roma, che pregustava l’apogeo della propria gloria terrena. Come chi sente d’esaurire l’energia vitale e non si risparmia, e dà tutto in un disperato rabbioso anelito all’esistenza, così Petronilla svelò e accolse splendidi tesori proprio negli anni che avrebbero visto scomparire il suo sacello.
Innanzitutto restituì sé stessa. Il suo sarcofago, smarrito in tempi remoti, fu ritrovato nel 1474 durante un restauro a spese di re Luigi XI. Restituì poi i suoi compagni di riposo, o almeno i loro averi. A più riprese, fino a metà Cinquecento, i ricchissimi corredi funebri depositati nella rotonda riemersero dall’oblio accendendo la curiosità dei contemporanei. E forse anche la loro cupidigia, se è vero che pressoché nulla è rimasto di quegli straordinari ritrovamenti. In cambio Petronilla ricevette arte sublime. Quella Pietà, lavorata dal ventitreenne Michelangelo e destinata a lungo peregrinare prima di guadagnare la postazione dove oggi si lascia guardare, a debita distanza e dietro uno spesso vetro antiproiettile.
Avviato il cantiere per la nuova basilica, l’appellativo di “cappella del re di Francia” passò al braccio meridionale del transetto in costruzione, che sorgeva sull’area dell’antica rotonda demolita a inizio Cinquecento. Probabile che il mantenimento del patronato servisse ad attirare le attenzioni, e i denari, dei sovrani di spettanza[8]. Fatto sta che la nuova configurazione non ebbe molto successo. Sovrintendendo ai lavori, l’ormai attempato Michelangelo conobbe una drammatica défaillance progettuale che gli costò stress e lavoro aggiuntivo come a un qualunque capomastro inesperto e distratto[9]. Il corpo di Santa Petronilla, intanto, restava nella basilica in cerca di una collocazione definitiva, mentre in giro per la città nuove fabbriche ecclesiastiche minavano la sua egemonia tra i Francesi nell’Urbe: sul Pincio il convento reale della Trinità dei Monti propiziato da San Francesco di Paola; in pieno centro la nuova chiesa nazionale di San Luigi. Peggio, qualche dotto in vena di prodezze filologiche iniziava a far circolare dubbi sulla parentela che tanta fortuna le aveva portato.
Una volta installata nella nobilissima posizione che vi ho detto, a destra della tomba di Pietro e prossima alla cattedra, Petronilla dovette aspettare il pontificato di Gregorio XV per ricevere adeguato ornamento. Una poderosa pala d’altare commissionata al Guercino, che restò in loco un centinaio d’anni prima di lasciar posto a una copia a mosaico. Come mai? Perché all’epoca la basilica di San Pietro era tutto meno che un luogo salubre. Spifferi, umidità, sbalzi di temperatura rendevano inospitale l’eterno cantiere, ufficialmente ultimato nel 1626, minando la salute dei comuni mortali e delle opere meno robuste.
Anche per queste praticissime esigenze di tutela, nella Fabrica si sviluppò un fiorente laboratorio d’arte musiva che consentì il salvataggio delle tele a rischio. Non tutto il bene venne per giovare però. Le pale sostituite dovevano essere spostate altrove. E la scelta cadde su Santa Maria degli Angeli, vastissima basilica ricavata da Michelangelo, ancora lui, dentro i resti delle terme di Diocleziano. Fu proprio per accogliere gli enormi dipinti che l’austero interno, dove la rovina classica giganteggiava possente senza rivali, cambiò connotati popolandosi, soffitto escluso, di lenocini settecenteschi che fanno un po’ rimpiangere, almeno a me, la perduta sobrietà.
La «Sepoltura e gloria di Santa Petronilla» girovagò, invece, tra Roma e Parigi, dove fu portata non come un dono al Paese d’elezione della patrona ma come preda di guerra dopo l’invasione francese dello Stato pontificio. Trovò pace nei Musei Capitolini grazie ad Antonio Canova, cui non dobbiamo solo tante levigatissime sculture ma anche una magistrale azione diplomatica per il recupero dei tesori razziati da Napoleone. Da quando il Comune di Roma ha introdotto la MIC Card, ingressi illimitati per un anno nei musei municipali al prezzo di 5 euro, salgo in Campidoglio come se scendessi al bar sotto casa. E allora andiamola a trovare, la nostra Petronilla barocca.
Sono passati oltre dodici secoli dal nostro primo incontro, ma non ha perso un frammento della sua grazia naturale. Tralasciando temporaneamente i suoi oneri di tutrice spirituale, ci mostra qui in un colpo solo quel che la volta scorsa aveva sottinteso: il suo seppellimento, circondata da becchini e spettatori, e, sopra, la sua incoronazione al cospetto di Cristo che l’accoglie nell’alto dei cieli. È raro che una santa ci faccia vedere il suo funerale. C’è chi dice l’abbia fatto perché il pubblico, da che mondo è mondo e ancor più in pieno barocco, vuole spettacolo. E lei, spentasi pacificamente nel suo letto, di scenografiche composizioni martiriali non può offrirne. Di nuovo quel favore divino che le si ritorce contro…
C’è anche chi dice che non si tratti del suo funerale, ma della sua riesumazione. L’ambivalenza della scena sarebbe servita a enfatizzare quel legame tra Petronilla e la Francia che aveva giustificato la nuova sepoltura in Vaticano. Ma a che pro? Si trattava di un omaggio a Parigi per compensare le simpatie filo-spagnole del papa regnante?[10] O forse il dipinto serviva a rivendicare che era Roma la custode delle spoglie mortali di lei, mentre in Francia si vociferava che reliquie di Petronilla giacessero da quelle parti? Era magari un modo per ricordare a re Luigi XIII i propri doveri di lealtà verso la Chiesa, laddove la geopolitica lo portava pericolosamente vicino ai Riformati mentre infuriava la Guerra dei Trent’anni?[11] Nel dubbio, mi concentro sul quadro.
Ingombra il fondo della sala dedicata, alto fin quasi al soffitto, sostenuto da una pesante armatura di legno e da catene per ancorarlo alla parete. Mi avvicino, nano di fronte alle figure che mi sovrastano. Avrò tendenze necrofile, non so, ma delle due Petronille preferisco quella cadavere. Non fosse per l’ambientazione e il colorito esangue parrebbe appennicata, la mano destra mollemente poggiata con sensuale realismo. La corona di fiori in testa, il casto décolleté e l’abito da ragazza acqua e sapone trasmettono un senso di tenera malinconia più che di lutto. Come certe popolane caravaggesche, sembra capitombolata per puro caso nel bel mezzo della storia dell’arte. Che i rustici necrofori che la circondano stiano lì per rianimarla dallo choc? La sua alter ego, lassù tra le nuvole, è piccina, delicata e di una sciccheria strepitosa, avvolta nei sontuosi drappeggi di un abito pensato per celebrare gli sgargianti colori araldici del pontefice. La stessa mano che vediamo in basso piegata e languidamente inanimata, qui si distende soave per tutta la lunghezza del dorso e delle dita, sottili e flessuose.
Buone notizie d’Oltretevere, intanto. Dopo una telefonata e qualche e-mail, l’autorizzazione dai palazzi vaticani è arrivata. Non mi resta che tornare da dove sono partito. A scortarmi da lei, aprendo una dopo l’altra le transenne abbondantemente disseminate tra navata centrale e presbiterio, è l’ispettore responsabile dei sampietrini. Stavolta non c’entra nulla la leucitite. Sono sampietrini in carne e ossa, questi, maestranze addette alle cose pratiche della basilica.
Davanti all’altare, galleggia sopra le nostre teste una grossa lampada perennemente accesa. Fu donata da Leone XIII per rinsaldare l’antico patto proprio mentre a Parigi allignava quella Terza Repubblica con cui i cattolici d’oltralpe recalcitravano assai a conciliarsi. A pochi metri da qui, nel Museo del Tesoro di San Pietro, c’è il regalo che a loro volta “i fedeli francesi” fecero al pontefice qualche anno dopo: un elaborato reliquiario contenente il cranio della santa.
Ho una netta sensazione di déjà-vu guardando lo pseudo-Guercino, in realtà Pietro Paolo Cristofari e scolari. È solo avvicinandosi molto che s’intuiscono le infinitesime discontinuità del mosaico: un tappeto di minutissime tessere vellutate composte di uno smalto opaco che fu brevettato apposta per riprodurre gli effetti cromatici e luministici della pittura a olio. Quante di queste pietruzze saranno servite per disegnare l’enorme Piccola Pietra immortalata sull’orlo della tomba? Con voluto illusionismo, il corpo bidimensionale sembra scivolare dentro lo stesso altare che custodisce, solido parallelepipedo, i resti terreni della santa.
Il viaggio volge al termine. Lo sguardo vaga sulle sterminate superfici di marmo variopinto. I volumi della maestosa architettura trasmettono una sensazione di riposo, di appagamento. Gli altri visitatori sciamano a decine di metri da noi. Tra qualche ora svuoteranno la basilica e i sampietrini si godranno i minuti quieti prima della chiusura: i più belli della giornata, confessa il mio accompagnatore. Mi torna in mente che qui, presso quest’altare, si celebra una messa per la Francia alla fine di ogni mese di maggio, nel giorno di Santa Petronilla. Pare sia un’occasione importante, presenziano le massime cariche diplomatiche d’oltralpe a Roma. Chissà che non venga a dare una laica occhiata, il prossimo anno. Speriamo solo che non piova. «Pluie de Sainte Pétronille, quarante jours mouillera nos guenilles»!
[1] Così chiama Petronilla quel gentiluomo di Giovanni Battista De Rossi, grande esploratore della Roma ipogea oltreché scopritore dell’affresco di cui scrivo e degli annessi e connessi: Bullettino di Archeologia cristiana del commendatore Giovanni Battista De Rossi, seconda serie, a. V, Roma, Salviucci, 1874, p. 123.
[2] Così si esprime il Martirologio romano nell’edizione in italiano del 1750, p. 111.
[3] Commodiano, Instructiones, 47, Fideles cavete malum, (https://www.thelatinlibrary.com/commodianus/commodianus2.html).
[4] L. Villani, Le borgate del fascismo, Milano, Ledizioni, 2012, pp. 70-82.
[5] 999contemporary, Big city life – Tor Marancia, Roma, Castelvecchi, 2015.
[6] http://www.iccd.beniculturali.it/it/194/fondi-fotografici/3903/michetti.
[7] Assomigliava ai mausolei della figlia di Costantino e della madre Elena, costruiti entrambi lungo il muro perimetrale di basiliche cimiteriali sorte presso catacombe in cui erano seppelliti martiri. Oggi la prima è una chiesa, Santa Costanza, mentre la seconda è Tor Pignattara. Al popolino romano bastarono una volta mezzo crollata e qualche scodella di terracotta in bella vista per far scadere un sepolcro imperiale a un torrazzo plebeo.
[8] I quali perderanno progressivamente interesse per l’affare: M.H. Weil, Saint-Jean de Latran. La chapelle de Sainte Pétronille et les privilèges de la France, «Revue historique», CXXXVIII (1921), pp. 214-223.
[9] A. Brodini, Michelangelo e la volta della cappella del re di Francia in San Pietro, in «Annali di architettura», 17 (2005), pp. 115-126; F. Sironi, Quell’errore di Michelangelo in San Pietro e le altre lettere: il tesoro dell’archivio Vasari, «L’Espresso», 2 maggio 2018 (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/04/24/news/vasari-uno-1.320946).
[10] L. Rice, The Altars and Altarpieces of New St. Peter’s, Cambridge, Cambridge U.P., 1997, pp. 47-54.
[11] L. Steinberg, Guercino’s Saint Petronilla, in «Memoirs of the American Academy in Rome», (1980), pp. 207-242; D. M. Unger, Guercino’s Paintings and His Patrons’s Politics in Early Modern Italy, London-New York, Routledge, 2016, pp. 85-93.