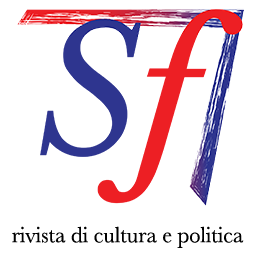É. Reclus, Storia di un ruscello, Milano, elèuthera, 2020, pp. 158, con una introduzione di Marcella Schmidt di Friedberg e un’appendice didattica a cura di Francesco Codello, tr. di Alberto Panaro, €16.
Vivendo una vita artificiale, hanno perso di vista la natura:
non sanno alzare lo sguardo per contemplare l’orizzonte e non lo abbassano neanche per guardare ai loro piedi. Ma che importa! Ciò che li circonda è forse meno bello a causa della loro indifferenza? (53)
Nel pieno della clausura internazionale la casa editrice milanese «elèuthera» ha ripubblicato in nuova edizione un classico del pensiero geografico e libertario francese ed europeo, la celeberrima Storia di un ruscello di Élisée Reclus (1830-1905). Scritto nel 1869, e poi pubblicato nella medesima collana editoriale che ospitava i romanzi di Jules Verne, questo agile saggio ibrido è capace di condurre il lettore dalle sorgenti alla foce tanto dell’eponimo ruscello quanto dell’umanità tutta: perché Reclus, ben prima che il dogma dell’interdisciplinarietà facesse capolino nell’agone accademica, aveva capito che la neutralità della scienza, nel suo caso geografica e cartografica, non era altro che un mito; o, come suggerito da Emilie Vilney in tempi più recenti, aveva capito che «quando [un autore] si posiziona come neutro e dice che è oggettivo, significa semplicemente che è di destra» (cit. in Borghi, Decolonialità e privilegio, 2020, 52).
E infatti, nel suo magistero scrittorio, Reclus non ha mai dimenticato per quale ragione scrivesse e, soprattutto, per chi. Il che non significa soltanto riferirsi a quella capacità di individuazione del «lettore modello» di echiana memoria, ma tanto cara anche all’ultima ruota del carro del marketing editoriale; al contrario: Reclus scriveva per cambiare un mondo strutturalmente attraversato da un’ingiustizia materiale ed economica, un’ingiustizia radicata nei rapporti di forza fra individui, ma ineludibilmente inscritta nello spazio, naturale e artificiale, in cui i suoi contemporanei spendevano le loro giornate.
Scrivere lo spazio, allora, significava raccontare l’essere umano (sociale e politico); e seguire «rasoterra» la storia di una «impercettibile gocciolina […] nei suoi giri e nei suoi salti, da quando appare nella sorgente fino a quando si mescola con l’acqua del grande fiume o dell’oceano» (28), voleva dire raccontare «la storia dell’infinito» (27). Reclus non scriveva (soltanto) per l’accademia; non scriveva (soltanto) per aggiungere un tassello di conoscenza alla cartografia del mondo; scriveva perché quella era la sua arma, il suo grimaldello per entrare nel reale e cambiarlo radicalmente.
Quando, terminata la clausura integrale, sono finalmente riuscito a mettere le mani sul libro, il caldo afoso di Bologna era già prepotentemente scivolato tra gli scatoloni del mio ultimo trasloco. Ho cominciato la lettura ricercando un poco di frescura sul mio piccolo balcone, affacciato sulla natura disciplinata di un parco di periferia. E lo spaesamento è cominciato: leggere questo libro in città, per quanto deserta possa essere Bologna nella terza settimana di agosto, è una forzatura, se non una contraddizione. Si vedano queste poche righe:
«la sorgente più alta e il prato che la circonda è, fra tutte le montagne, il luogo più delizioso per eccellenza! Ci si trova al limite tra due mondi; da una parte, al di là dei promontori boscosi, appare la ricca valle con le sue coltivazioni, le sue case, le sue acque pacifiche e la foschia indistinta che incombe sulla città lontana; dall’altra si estendono i pascoli solitari e la vetta s’immerge nell’azzurro profondo del cielo. L’aria è corroborante e leggera: quando si alza dall’alto e si vede sullo sfondo l’aquila che si libra sulle sue ali robuste, verrebbe voglia di volare come lei al di sopra delle campagne e delle colline, lasciando che lo sguardo vaghi da lassù sulle piccole opere dell’uomo. Quante volte, per il piacere di guardare più che per la dolcezza del riposo, ho poggiato i gomiti accanto a una sorgente di montagna e ho girato lo sguardo dalla fonte solitaria al grande mondo laggiù, che si perde in lontananza verso la cerchia infinita dell’orizzonte!» (59).
Da tale immenso otium paesaggistico agli ailanti cresciuti nel cemento di via Magazzari il salto è vertiginoso. Non tanto per una mia particolare avversione per gli alberi del paradiso che, anzi, stimolano tutta la mia empatia, ma per la cocente delusione di vedere che quasi centocinquant’anni dopo la pubblicazione della Storia, ancora viviamo una realtà in cui cemento e dominio sociale vanno a braccetto. Dopo mesi reclusi in casa e altrettanti giorni spesi alla finestra, combattuti fra un nobile richiamo alla responsabilità collettiva e il richiamo di pancia all’avventura collinare, leggere della libertà genuina di un uomo che, per fare scienza e politica (che in fondo, per lui, sono la stessa cosa), è steso accanto a una sorgente, appoggiato sui gomiti a guardare il volo concentrico di un rapace, è un po’ più che perturbante: è fonte di invidia e, insieme, di scoramento. Viene insomma da pensare che il «noi» di cui Reclus sta parlando riguardi in prima persona anche noi esseri umani del 2020: «noi barbari, che vediamo solo i vantaggi del traffico, ammiriamo i fiumi soprattutto in proporzione al numero di sacchi o di barili che trasportano ogni anno, e non c’interessiamo granché dei corsi d’acqua secondari che li formano e delle sorgenti che li alimentano» (53).
Ed è probabilmente questa passione per i modesti affluenti che spinge Reclus a scrivere la storia di un ruscello, il suo normalissimo frankenstein. Come leggiamo nelle prime pagine, esso «non ha nulla che lo segnali particolarmente all’attenzione degli uomini. Non nasce dalle alte montagne ricoperte di ghiacci; le sue rive non offrono una vegetazione particolarmente rigogliosa; il suo nome non è celebre nella storia»; almeno, «è grazioso; ma quale ruscello non lo è?» (55). Esso tuttavia, o almeno questa è la mia impressione, non esiste come individualità. Il ruscello raccontato da Reclus è un frankenstein, il frutto della sapiente giustapposizione di diverse esperienze dello scrittore, siano esse il frutto di viaggi o letture.
Volendo fare le cose in grande, si potrebbe paragonare il modesto ruscello di Reclus a un discorso attribuito a Demostene e risalente al 339/8 a.c. L’orazione, nella quale Demostene sosterrebbe le ragioni della guerra contro la Macedonia, nelle parole di Luciano Canfora, è infatti un «falso vero» (Canfora, La storia falsa, 2008, 16 e sgg.). Ideato da Anassimene nella sua opera storica, questa filippica «spuria», frutto di un accorto lavoro di collage di discorsi e opere effettivamente prodotti da Demostene, sarebbe confluito nella raccolta delle filippiche quasi per sbaglio, per un eccesso di zelo da parte di un antico che voleva completare la raccolta delle opere dell’oratore ateniese. Insomma, quanto è arrivato fino a noi è un discorso vero nella misura in cui le parole che vi ritroviamo furono effettivamente scritte da Demostene; falso, perché non fu lui a porle in quell’ordine preciso. Il ruscello di Reclus, a suo modo, sembra seguire questa medesima logica: esso è vero nella misura in cui, a un certo punto della sua vita, Reclus ha probabilmente esperito una delle tante caratteristiche che attribuisce a questo ruscello «grazioso»; falso, in quanto non è mai esistito un singolo corso d’acqua che le assommasse tutte. Un frankenstein, dunque; la creazione ex novo di un discorso scientifico fondato sull’osservazione diretta e sulla ricomposizione ex post.
Ma in fin dei conti chi se ne importa. Questo ruscello di cui Reclus racconta la storia e le anse, dalla giovinezza alla maturità, è un ruscello portatore di uno sguardo lungo; tanto lungo, che la narrazione che vi galleggia a pelo d’acqua è intessuta di continui zoom in/zoom out. Un esempio di questo meccanismo applicato al livello spaziale, d’altronde, lo abbiamo già visto: dai gomiti appoggiati sull’erba allo sguardo vigile dell’aquila che solca i crinali innevati. Ma gli esempi non lesinano: fin dalle prime pagine Reclus sembra volerci mettere in guardia da una geografia a livello del terreno, il che non contraddice, per inciso, l’idea di una geografia rasoterra o, come si direbbe in inglese, una geografia grassrooted: «stesi comodamente sull’erba di un prato, accanto all’acqua che scorre gorgogliando […] lasciamo vagare la mente molto più lontano dei confini in cui è costretto lo sguardo. […] Seguiamo nel suo volo al di là delle montagne e dei mari l’uccello che fugge verso un altro continente» (39). O ancora, appena dopo averci introdotti allo sguardo che può posarsi sulle prime anse del nostro ruscello, Reclus non può esimersi dal ricordare che «le brusche pendenze, i promontori sporgenti, non permettono di cogliere con lo sguardo la disposizione del paesaggio […]; ma se ci librassimo come un uccello o ci dondolassimo nella navicella di un pallone aerostatico, vedremmo… » (56). Una visione, abbiamo detto, in non contraddizione con l’idea di una geografia rasoterra: camminare, per Reclus, non significa abdicare alle altezze raggiungibili dal volo, ma riconoscere l’immensità racchiusa nella modestia e nel minuscolo della goccia: perché «anch’essa è un mondo» (27).
Se il continuo cambio di registro dallo sguardo del camminante a quello dell’uccello è un meccanismo di comprensione complessiva del paesaggio, composto di sguardi d’insieme e minuscole prospettive oblique, il frequente ricorso allo strumento dello zoom assume diversa funzione quando applicato a temi storico-sociali. La Storia (e la maiuscola non è casuale) è per Reclus una storia di dominazione e sopraffazione, ma intessuta di pratiche (sommerse) di resistenza. Come per il suo collega e amico Pëtr Kropotkin, per Reclus «gli individui che hanno fatto la storia non sono soltanto quelli che gli storici hanno rappresentano come eroi» (Kropotkin, Il mutuo appoggio, 2020, 45), ma «i sofferenti della terra». Questi ultimi, nel libero scorrere del ruscello, non hanno solo trovato refrigerio al calore o alla sete; hanno trovato un mezzo di contrattacco. Fare la storia del ruscello così, arriva a somigliare moltissimo a fare una storia della lotta fra dominanti e dominati nel corso dei secoli: «Se gli oppressi non avessero potuto ritemprare la loro energia e rifarsi un’anima con la contemplazione della terra e dei suoi grandi paesaggi, già da tempo l’iniziativa e l’audacia sarebbero state completamente soffocate. Tutte le teste si sarebbero chinate sotto la mano di pochi despoti, tutte le intelligenze si sarebbero impigliate in una rete inestricabile di sottigliezze e di menzogne» (31).
Il passaggio repentino dalla descrizione della sorgente del ruscello a queste considerazioni di carattere più generale e, potremmo dire, antropologico ha così la funzione di radicare il discorso di Reclus nella pratica dell’azione diretta della scrittura. Il sottotesto, nemmeno troppo implicito, è allora che il libro che si ha fra le mani e che si è appena iniziato a leggere, non è un testo neutro: la conoscenza che vi è contenuta è connotata ma non ideologica nella misura in cui non vi sono nascondimento e menzogna.
Assai simile si fa il discorso quando Reclus, cercando di ricostruire «i meandri del ruscello […] con l’immaginazione» (75) si addentra in una piccola grotta. Qui, il meccanismo dello zoom assume dimensione siderali, riuscendo lo sguardo del geografo a tenere insieme le profondità della storia e i tempi geologici di stalattiti e stalagmiti. In un’incredibile spirale retorica Reclus ci prende per mano e accompagna in una storia dell’umanità mossa da un piccolo spostamento: «basta qualche passo per essere trasportati in un altro mondo». E così, lì dove «tutti gli oggetti assumono proporzioni fantastiche [e] un piccolo buco che si apre nella pietra sembra un abisso, una roccia che scende dalla volta sembra una montagna rovesciata, le concrezioni calcaree intraviste qua e là assumono l’aspetto di mostri enormi», lì, «erano i rifugi dei nostri antenati». E verso tali preistorici antenati Reclus dimostra una riconoscenza assoluta: «probabilmente, fra quei resti umani […] nessuno racchiudeva il cervello di un Eschilo o di un Ipparco, ma né Ipparco né Eschilo sarebbero esistiti se i primi trogloditi […] non avessero prima di tutto conquistato il fuoco strappandolo al fulmine o al vulcano. Se non avessero intagliato armi per ripulire la terra dei suoi mostri e non avessero così […] preparato per i loro discendenti le ore di tregua durante le quali si elabora il pensiero» (64-69).
La grande famiglia umana, allora, esula dai contemporanei di Reclus: se la storia è opera collettiva, e non il frutto di pochi geni, anche gli abitanti della preistoria hanno un posto d’onore in questa narrazione. Ma se vi ritroviamo gli antichissimi pittori di caverne, non per questo possiamo dimenticare chi, ancora oggi (e qui si apre una fertile discrasia fra l’oggi odierno e l’oggi narrativo), sottoterra è costretto a vivere: «certo non osiamo dire che ai nostri giorni la vita sia diventata meno faticosa per tutti gli uomini. Fra di noi, moltitudini ancora diseredate, vivono nelle fogne che escono dai palazzi dei loro fratelli più fortunati; migliaia e migliaia di individui abitano in scantinati e bugigattoli umidi, in grotte artificiali molto più insalubri delle grotte naturali in cui si rifugiavano i nostri antenati» (69). E tuttavia, complice l’illimitata fiducia nel progresso umano manifestata da Reclus, «dobbiamo riconoscere che i progressi compiuti sono tanti» (69).
Insomma, guardando al ruscello, Reclus riesce a mostrarci insieme un modello teorico e un modello di metodo. Teorico, nella misura in cui indica nel continuo rapporto fra micro e macro la struttura profonda del reale (sia esso biologico o sociale); di metodo, perché l’unico modo per capire questa dialettica spaziale e narrativa è lasciare che l’acqua ci scorra sulle mani e che il terreno umido rechi traccia dei nostri scarponi. Il «laboratorio delle sorgenti» (94), così, non sarà più soltanto lo spazio chimico di reazione degli elementi, ma un nuovo modello di relazione antropologica fondato sui principi di libertà e uguaglianza.