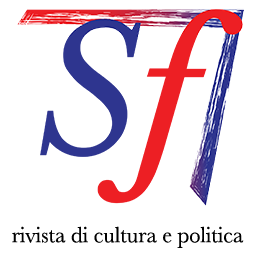In Lo Stradone di Francesco Pecoraro (Ponte alle Grazie, 2019) si può ritrovare lo spirito di Balzac. Questo romanzo risponde, infatti, innanzitutto, alla funzione di comprensione sociologica del nostro tempo. Certo, passata attraverso il Novecento, la forma del romanzo è segmentata. La voce narrante, ora interna, si moltiplica. I registri si susseguono e i generi si alternano. Gli elementi originali del romanzo ottocentesco si presentano qui nudi: frammenti narrativi, dialoghi, osservazioni morali, dissertazioni urbanistiche, ricostruzioni storiche, estratti di saggi scientifici. Si ritrova, cioè, un Balzac disincantato che non crede più nella possibilità di amalgamare le diverse componenti in un romanzo o in una lunga serie di romanzi omogenei e coerenti. Il narratore è consapevole che il proprio modo di pensare non è che uno fra i tanti. Racconta «quello che ho scrutato per tutta la mia misera vita di flâneur doo stradone» e ne dà la sua interpretazione. Anche a livello narrativo, l’unità è irrimediabilmente distrutta: tre diverse linee narrative danno vita a un romanzo che cattura il lettore senza quasi mai ricorrere alle consuete tattiche della suspense.
Fra i diversi elementi di conoscenza e godimento che il romanzo offre, vi è la storia di un quartiere di Roma: valle Aurelia, conosciuta anche come valle dell’Inferno. Un’attenzione, verrebbe da dire microstorico-sociologica, per i luoghi, che indugia sul fascino decadente del «terzo paesaggio» (il paesaggio in cui la natura torna a nascondere le opere umane), laddove si dà una sorta di sospensione dello spazio urbano della capitale. Il narratore ci racconta la storia di questo luogo fin da epoche preromane, in un linguaggio tutto suo in cui nomi sempre evocativi e mai reali rendono epicamente universale un’evoluzione assolutamente peculiare. I racconti si fanno più dettagliati man mano che ci si inoltra nell’epoca moderna per appassionarsi ai momenti chiave di quella che diviene, nonostante la posizione relativamente centrale, una borgata caratterizzata dal ciclo estrattivo dell’argilla e produttivo del mattone. Materiale essenziale per committenti ecclesiastici o laici e ampie schiere di palazzinari. Cave e fornaci, operai (o «roboti», nel linguaggio dell’anonimo narratore) e comunità di quartiere. La memoria storica del narratore, in pensione e che mai ha vissuto quella realtà operaia, stride con il presente del suo Stradone, del non-quartiere residenziale sorto ai bordi di quella che era la borgata operaia rasa al suolo dopo la, si direbbe oggi, delocalizzazione della produzione. Come il narratore stesso ammette, il suo punto di vista è quello di un vecchio marxista, ma è un marxismo ormai senza corrispondenze nella società che lo circonda. Un marxismo quasi irriflesso cui rimane istintivamente fedele, nonostante una breve adesione opportunistica al craxismo rampantemente corrotto. In questo marxismo irriflesso e avulso dal mondo circostante, divenuto disilluso e cinico, si rispecchia ulteriormente uno dei temi centrali del romanzo: la contrapposizione fra il passato delle classi e la nuova struttura sociale.
«Nella seconda metà degli anni Ottanta del Ventesimo Secolo, quando la vicenda industriale, insediativa e politica del Quadrante è praticamente terminata e i roboti che l’hanno vissuta sono in pensione o sono morti e i loro figli, affrancati dalla fornace, sono da tempo usciti dalla Sacca in cerca di altri lavori e i figli di questi figli abitano altrove e non sanno praticamente più niente di ciò che vi accadde, squadre di sociologi cominciano a studiarla. Nel momento in cui la pentola della Storia smette di bollire si mette in moto l’accademia e comincia a raccogliere i cocci sparsi dappertutto, mette al sicuro testimonianze, ricostruisce i dati ambientali culturali produttivi, ricompone per quanto possibile il quadro generale e, quando ci riesce, alcuni destini individuali. E lo fa implicitamente naturalmente inevitabilmente parteggiando per i roboti, come del resto farò io riferendo di seconda mano le testimonianze e a mia volta immaginandone alcune.» [p. 177]
Il narratore svela le sue carte. Come nella migliore tradizione, il romanzo sociologico scaturisce da studi accademici, osservazioni dirette e invenzioni; qui, però, in una mise en abîme, tale intreccio viene affidato a una voce narrante fittizia che si limita a sovrapporre o giustapporre testimonianze, analisi sociologiche storiche urbanistiche, rapporti tecnici e proprie invenzioni (il riferimento preciso ai lavori storico-sociologici che lo scrittore fornisce al suo narratore sono elencati in una “Nota” finale). Le ricostruzioni storiche (dedicate principalmente al secolo industriale 1880-1980) s’intrecciano ad altri piani temporali: i passati più recenti del narratore (anni Settanta, Ottanta e Novanta) e il presente (gli anni dieci del nuovo millennio). All’analisi scientifica attraverso cui, a partire dagli anni Ottanta, sociologi e storici hanno studiato valle Aurelia come un oggetto di studio isolato per restituirgli poi il suo contesto e cercare così di ricostruire un’unità, Pecoraro contrappone un altro modo di concepire la storia. Dà voce a un narratore che deliberatamente frammenta e incastra voci, testimonianze, fonti. Si scopre allora che, a ben guardare, dietro all’ostentata frammentazione formale del romanzo, prende vita un’altra unità: nel contrasto continuo fra temporalità diverse, si ricompone un’unità storica alternativa a quella dell’ordine cronologico rigoroso e asettico. Non si gioca affatto con gli anacronismi (coscientemente evitati), ma si lascia emergere la continuità e la discontinuità dell’esperienza storica. In un contrasto ulteriormente accentuato dal basso continuo di dialoghi fuori tema colti al bar del nuovo post-quartiere, riprendono vita i passati di quell’angolo di Roma: la costruzione delle fornaci, l’inizio della sindacalizzazione, una (immaginaria) visita di Lenin di ritorno da Capri nel 1908, l’opposizione rude ai fascisti nel 1922 e indiretta al regime nel ventennio, la Resistenza, il Partito, gli scioperi dei primi anni Sessanta, e poi il trasferimento della produzione, la precoce fase post-industriale iniziata a metà dei Settanta e, infine, la definitiva estinzione della coscienza operaio-comunista e la parallela trasformazione/distruzione urbanistica voluta da un’amministrazione in quel momento guidata dal Partito.
In questo evocare alla vita i passati, il narratore non manca di cogliere gli aspetti diversi e contradittori di quella valle industriale a qualche centinaio di metri dalla cupola simbolo e centro della cristianità cattolico-romana: l’auto-organizzazione, l’eroismo antifascista, l’etica del lavoro e la costruzione di una cooperativa operaia, ma anche la tensione con le dottrine “ufficiali” del socialismo otto-novecentesco, l’isolamento estremo di quelle esperienze, il senso di soggezione profonda che accompagnava gli operai fuori dal loro ristretto contesto, la quotidiana violenza di genere o il rapporto complesso con il PCI.
Senza idealizzare il passato, il narratore coglie un punto essenziale delle classi sociali e di come, in particolare la classe operaia, funzionasse: non l’essenza della comunità, ma la proiezione immaginaria di una comunità. Proiezione mobilizzatrice, condizione necessaria della lotta di classe. Proiezione che si fonda su un dover essere storico, politico e morale. Ben sapendo di non essere ancora ciò che aspiravano ad essere, gli operai e le operaie avevano un’idea di classe che costituiva un modello ideale e normativo. Bisognava essere all’altezza della missione storica che si era assunta. Nel contrasto continuo col presente, il narratore anonimo di Pecoraro tratteggia il nostro presente e, implicitamente, una dimensione essenziale di ciò che era la classe operaia:
«Qualcuno sta lavorando sulle nostre menti di ceto medio esteso e, senza più mediazioni di partiti intellettuali giornalisti preti, le conduce facilmente nel proprio ovile. Il fenomeno si osserva bene anche qui, dove si sta facendo spazio qualcosa di naturale e profondo, che reagisce alle sfide della realtà come un serpente spaventato e messo alle strette. Sulle prime mordiamo alla cieca, ma poi lentamente ci adattiamo, perché non abbiamo sensazioni di minorità, nessuna insoddisfazione, nessun conflitto di classe, nessuna tensione di superamento, nessun progetto politico cui aderire, nessuna visione d’insieme, nessun futuro, non ce ne frega di niente e di niente, viviamo per vivere. Non sentiamo di avere un gap di censo, di cultura, da colmare con chissà quale casta superiore. Le caste ci sono, ma so’ solo maniche de ladri da cacciare. Noi ci andiamo bene come siamo fatti.» [p. 295]
Duecento anni più tardi la funzione della letteratura si conferma essere quella balzachiana: un linguaggio della sociologia (allora nascente), un tentativo di comprendere la società e il suo movimento storico. La parola è, però, data a un narratore estraniato, che scruta i suoi simili e le loro vite il cui spazio-tempo sembra irreversibilmente ridotto all’«accudimento quotidiano del corpo e della nostra capsula abitativa dove noi, umani-mollusco dello Stradone, troviamo protezione alla nostra nudità biologica, proprio come fanno i polpi» (p. 235). La Comédie humaine ambiva a una descrizione delle tipologie umane della società francese del tempo e la sua coerenza-unità era garantita dal narratore omnisciente. Balzac disse, scrivendo la sua prefazione a posteriori, che, al momento d’intraprendere la monumentale opera, «la Società francese sarebbe stata lo storico, io non dovevo che essere il segretario». L’umile ruolo di segretario veniva rivalutato già nelle righe seguenti: da vero scrittore, l’ambizione e la responsabilità non poteva che essere quella di cogliere il senso stesso della storia: «così dipinta, la Società doveva portare con sé la ragione del proprio movimento». In Lo Stradone, il narratore estraniato propone una delle possibili sintesi delle tipologie sociali che animano la narrazione. La spiegazione generale (l’ideologia) si è persa con la fine delle identità di classe, così come l’impressione che la società trovi il suo senso nel movimento storico:
«Il mondo che osservo qui sullo Stradone, ma di cui soprattutto apprendo l’esistenza in tv, nell’internet, sui morenti giornali, lo immagino come un panino a tre strati: il pane sopra, il grande ripieno sociale e il pane sotto. Il ripieno che sta nel mezzo funge da nutrimento sia per lo strato inferiore che per quello superiore. Il cambio di un senso (impossibile) di sicurezza e un po’ di reddito, gli intermedi sono pronti a cedere un po’ di libertà, verità e realtà. Gli altri due grandi strati sociali – quello superiore è più sottile – sono costituiti da gente che non vive secondo le regole e ciò per due ragioni: o perché hanno soldi e potere e ne possono fare a meno, oppure perché sono poveri e emarginati e immigrati e le regole le ignorano o non possono, o non vogliono, rispettarle. Lo strato sociale mediano, che disprezza gli indigenti anche se prova pietà e carità, mentre ammira i facoltosi e i potenti, è la mucca da mungere: produce risorse e ne cede la più parte agli altri due. I poveri e non-garantiti vivono del percolamento verso il basso di una piccola porzione di ricchezza, mentre quelli che stanno sopra, i dominanti, per lo più defilati e occulti, se ne prendono una bella fetta. Voglio completare questa rozza immagine, di cui fornisco qui sopra un maldestro grafico, con una rete criminale, estesa e ramificata come le venature di grasso di una buona bistecca, che vive in rapporto simbiotico con tutti e succhiando risorse ovunque, investendo e riciclando e mescolando le proprie attività con quelle legali.»[pp. 167-168]
Se il giubbetto multitasche diviene il centro di un intero capitolo è allora proprio perché l’analisi sociologica interroga la società osservando le identità delle sue parti e i mezzi con cui queste identità si affermano e si distinguono nel quotidiano. Il senso stesso della moda si ridefinisce nella società in cui le fratture sociali non si esprimono più nei codici delle classi, delle redingote e delle bluse, dei colletti bianchi e delle tute blu. Da sociologo, lo scrittore osserva abiti e costumi, mœurs e vices. Balzac descrisse la società in cui viveva nella speranza mai persa che il liberalismo costituzionalista, la democrazia e quello che avrebbe preso il nome di socialismo non fossero che sintomi passeggeri di una crisi sociale, ovvero morale, da cui la Francia avrebbe potuto riscattarsi. Ma nel descriverla colse diversi aspetti fondamentali di quella che si rivelerà una transizione irreversibile verso la società liberal-democratica. Colse, cioè, senza volerlo e ancor meno condividendolo, la «ragione del movimento». Come dire che il romanzo prima di rivelarsi borghese si sarebbe voluto aristocratico. Il narratore del tardo marxismo-cinismo, si ritrova protagonista di un’impresa altrettanto paradossale.
«Di solito noi del ceto medio esteso non ci raccontiamo per come davvero siamo, credo ci interessi poco. Il grande ripieno sociale si trova noioso: benché sia attraversato da spietate e selvagge pulsioni, fa finta di no e, fatte salve le sit-com di ogni ordine e grado, cinematografiche e televisive, non si trova interessante se non per ridere. Siamo uomini e donne che vivono soprattutto di rapporti orizzontali, cioè interni allo strato sociale e alle capsule di appartenenza, senza un’esperienza diretta, se non fugace e marginale, della vita degli strati superiori e di quelli inferiori. Quindi tutto ciò che sappiamo dell’ ‘altro da noi’ lo sappiamo per interposta fiction.» [p. 201]
L’impresa paradossale è quella di narrare il ceto medio esteso, il «ristagno», l’assenza di movimento. Di narrare ciò che lui stesso, narratore disilluso e impaludato, dichiara essere inenarrabile. Resta forse la speranza, nel lettore almeno, che si colga involontariamente il movimento storico e una sua ragione. Ma come sbotta un anonimo avventore del bar di valle Aurelia, «nun me rompete er cazzo, oggi posso parla’ solo de Totti».