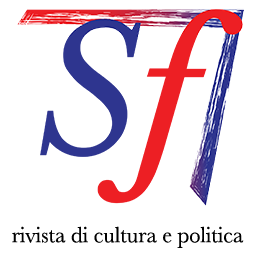«Santa Maria, madre di dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen». Calcolo mentalmente quanti anni potrebbero essere trascorsi dall’ultima volta che ho recitato un’avemaria inginocchiato sul banco di una chiesa. Arrotondando per eccesso, dovrei attestarmi sul quarto di secolo. Assiste all’epocale evento un’amichevole suora ugandese, cui già non ho potuto rifiutare un padrenostro senza entusiasmo. Dal banco accanto detta il ritmo e passa alla preghiera successiva, che ignoro totalmente. Faccio scena muta stavolta. La sequenza è terminata. Segno della croce. Arrivederci e grazie.
Indottrinato dalla mia guida, ho appena attraversato le stanze di san Luigi Gonzaga in un percorso turistico-confessionale che quadro per quadro, reliquia dopo reliquia, altare appresso ad altare, mi ha raccontato come si fa in soli 23 anni di vita terrena a passare dai vertici dell’aristocrazia mantovana a quelli dell’organigramma devozionale romano. Nonché a diventare protettore dei giovani studenti. A scoprirlo per tempo avrei magari fatto carriera ’na ’nticchia prima. «Prego tanto» mi ripeteva ossessivamente mia nonna buonanima per consolarmi dell’interminabile precariato. Devota ad Antonio da Padova, purtroppo sprecava tempo e fiato. Quando si dice non sapere a che santo votarsi…
Mi trovo ai piani alti del Collegio romano, già centro di formazione gesuita oggi in gran parte occupato da un liceo statale e dal Ministero della cultura. L’ex cappella universitaria a pianoterra è la chiesa di sant’Ignazio, nel cuore del Campo Marzio. Che ci crediate o no, non sono in preda a malcelate crisi mistiche ma nel bel mezzo di un’esplorazione urbana sulle tracce di uno dei massimi scultori del tardo barocco. Esuberanza dinamismo introspezione serena potenza si fondono al suo tocco. Si chiamava Pierre Legros e veniva d’oltralpe. Un parigino a Roma. Classe 1766. Figlio d’arte. Ce lo descrivono alto, belloccio, incline alla malinconia, buon conversatore le rare volte che parlava. Geloso della propria creatività in un’epoca in cui chi concepiva l’opera (invenit) non era meno importante di chi la eseguiva (fecit). Arrivò in Italia intorno ai 24. Si gettò a capofitto nel turbinoso fiorire di santi e presuli che faceva ancora dell’Urbe la mecca artistica del tempo. E non ne uscì più[1].
Prendo commiato dall’esotica accompagnatrice, recupero l’aplomb investigativo e mi avvio tra corridoi e scale verso l’aula liturgica della chiesa di sotto. Famosa per la cupola che non c’è. O meglio: c’è ma non come ce la si aspetterebbe. Qui all’architettura si sostituisce la pittura in una delle illusioni prospettiche più celebrate della storia. I turisti s’assiepano intorno al punto focale da cui s’apprezza il gioco. Strano che a Roma con tutte le cupole che ci stanno proprio i Gesuiti si siano dovuti accontentare d’una poverata del genere. Abilissimamente sublimata. Opulenti. Saccenti. Ma resilienti quando necessario.
Devio verso l’altare del transetto destro, che negli spazi enormi dilatati dai trompe-l’oeil quasi non si nota. Qui Andrea Pozzo, factotum in house, mette da parte le sofisticherie ottiche e squaderna un doppio frontone su colonne tortili di proporzioni basilicali. Al centro una pala marmorea di Legros. È un rilievo profondissimo dallo stiacciato al tuttotondo. Scarto rapidamente l’ipotesi d’arrampicarmici per andare a prendere le misure e conto a occhio un metro o poco meno tra le sporgenze più aggettanti e il fondale. Davanti a tutti, al centro della rappresentazione, il Gonzaga fluttua su un cuscino di nubi e angioletti abbarbicati, ascendendo al cielo.
Nato nobile e designato militare, Luigi aveva rinunciato a tutto in nome delle opere pie. Morì di peste, contratta per lo zelo nell’assistere i malati. La sua abnegazione lo rese martire della carità nella Roma controriformista. Quando l’immane altare era ancora in costruzione, il defunto era tale da oltre un secolo. Precisamente dal 1591. I suoi resti erano qui ben prima che c’arrivasse l’involucro meraviglioso pensato per rimpiazzare la vecchia chiesa, ormai angusta. Tramontava il Seicento, s’avvicinava il Giubileo, terminavano i lavori dell’altare. Un tripudio di materiali preziosissimi custodisce da allora le spoglie. Escluse le reliquie disseminate in Italia e altrove.
Quatti quatti, ai lati dell’urna si agitano due paffuti marmocchi. M’interrogo su cosa combinino. Soccorre didascalia. Uno ha deposto ai piedi l’emblema dell’eredità politica cui Luigi abdicò: la corona di marchese di Castiglione delle Stiviere. L’altro calcia lontano un pallone di lapislazzulo, ovvero un globo terracqueo, come a dire: via la mondanità e le sue mefitiche tentazioni. In mano ha un’altra corona, stavolta di fiori: simbolo di martirio. Sono anche loro di Legros. Me lo immagino lì a tratteggiare le curve grassocce di questi infanti da contemptu mundi pensati per affiancare un’urna stellare.
Il massimo dello sfarzo terreno per additare umiltà, abnegazione verso il prossimo. Tornato a casa, letture sparse mi fanno riflettere sul fatto che forse uno sforzo per svincolarsi dal paradosso Legros l’aveva fatto.
La gloria di san Luigi Gonzaga non è tanto un’apoteosi ultraterrena quanto una festa intima. A guardarlo meglio, il protagonista tiene gli occhi bassi, lontanissimo da ostentata estasi o trance mistica. Il fasto che lo contorna è tenuto a debita distanza da una discrezione appagata che guarda alle piccole povere cose di qui. La santità di Legros disprezza il mondo nei suoi rapporti di forza secolari ma ne cura amorevolmente patimento e dolori. Profluvio di ricchezze perché così non si può non fare secondo moda, ma la sostanza etica è tutta pauperismo e misericordia.
È un’esplosione talmente anestetizzata da indurre qualche sospetto. Luigi ricorda quei calciatori che festeggiano il gol con braccino alzato e corsetta asfittica, magari dopo un calcio di rigore ininfluente.
Al tempo in cui Legros spopolava a Roma, la cattolicità era attraversata da una polemica dottrinale sfociata nel politico. Rivaleggiavano giansenisti e papalini intorno alla natura della santità. Per i seguaci di Cornelius Jansen non si è buoni senza che l’abbia deciso dio. Così che le opere terrene possono solo inverarne le intenzioni. O sei eletto o resti irretito nelle maglie della tua congenita malignità. Si sa che di giansenisti era piena la Francia. Sia mai che Legros abbia in qualche modo infuso nel suo Luigi la serena autocoscienza del predestinato?
Ne dubito ma chissà. I fatti ci dicono in realtà che lo scultore parigino era un beniamino dei Gesuiti, noti ultrà del papato e nemici giurati di giansenismo e ogni altra eterodossia. La prodezza che lo rivelò al pubblico romano fu, manco a farlo apposta, l’allegoria della (vera) Religione che sconfigge Eresia: una casta Wonder Woman armata di croce e nembo infuocato sbaraglia un’ossuta vegliarda dai capelli di stoppa e un energumeno armato di serpente. La capoccia del rettile spunta dal groviglio ad aggredire lo spettatore con una ghigna che è il massimo della cattiveria. Completa la scena un imbufalito pargolo che s’accanisce su un libro di «Zwingli» riducendolo a brandelli. Quelli di «Calvin» e «Luther», non lontani, faranno presumibilmente la stessa fine.
Il tutto sorge a fianco dell’altare dedicato al fondatore sant’Ignazio nel principale feudo della Compagnia: la chiesa del Gesù. Manca all’appello la statua d’Ignazio che Legros realizzò nell’argento e che fu ridotta a mal partito durante la Repubblica Romana nel 1798. Paziente ricucitore delle bellezze romane dopo lo tsunami della Rivoluzione e di Napoleone, Antonio Canova ne coordinò il ripristino. In stucco argentato stavolta. Dell’originale si salvò soltanto la pianeta. Chi volesse può ammirare il pasticcio recandosi sul posto e assistendo al coup de théȃtre partorito dalla mente fervida di Andrea Pozzo. La pala d’altare che s’abbassa, musica sacra, luci d’atmosfera e… tac! Spunta lui: Ignazio in gloria. Stavolta in posa assai scenica, con braccia larghe e sguardo al cielo. C’è chi tra gli esegeti azzarda sia meglio l’integrazione canoviana[2]. Questione di gusti o malcelato patriottismo?
La procedura d’appalto fu per l’epoca un raro esempio di peer-review: erano gli stessi dodici competitori a valutare i rispettivi lavori e a scegliere il migliore. Un po’ come a Cuochi d’Italia ma senza Alessandro Borghese e il voto che «potrebbe confermare o ribaltare la situazione». Il giorno in cui Legros vinse il concorso, con relativi cento scudi di premio, «la numerosa squadra de’ giovani francesi che l’aspettava» fuori da Casa Professa lo accolse a suon di «Viva viva monsù Le Gros»:
«Scendeva egli allora giù per la scala con in mano il sacchetto delli cento scudi in tante piastre, che scuoteva per farle sentire, ma giunto appena al cancello di detta scala, che mette nel piano, la gioventù francese affollatasegli d’attorno e levatolo di peso, il portarono come in trionfo, rinnovando tratto tratto il viva. Lo strepito straordinario che faceano nello girar per le strade chiamava il popolo, il quale domandava che cosa volesse dire quella novità.»
Finì che Legros pagò a tutti da bere[3]. Passata la sbronza, venne a galla un inghippo burocratico fin lì ben nascosto.
Legros era all’epoca membro dell’Accademia di Francia a Roma. Stipendiato del Re Sole. Uno statuto da privilegiati, per il quale si prevedeva fedeltà esclusiva e grata. L’Accademia era però in crisi. Il re spendeva troppo in guerre e i denari per artisti e docenti scarseggiavano. Quando a conti fatti Legros rivelò il servigio per i Gesuiti al direttore dell’Accademia questi cercò d’indorare la pillola coi capi oltralpe, anche per salvare sé stesso e la propria maldestra sorveglianza. Ma non poté far altro che licenziare l’insubordinato per rispettare l’etichetta impostagli dai piani alti. Letterato prestato alla burocrazia, in privato lasciò trasparire l’apprezzamento per l’estro dell’artista. Il gruppo scultoreo a sinistra dell’altare di sant’Ignazio, speculare a quello di Legros, era stato scolpito dal connazionale Jean-Baptiste Théodon, di vent’anni maggiore e ben più inserito nell’ambiente. Il lavoro di Legros «a esté trouvé le mieux disposé d’abord», scrive il direttore al ministro competente a Parigi, «le mieux entendu, en un mot le meilleur»[4]. Concordo. Per giunta a Théodon i giudici del concorso avevano rifiutato il primo bozzetto e al secondo aveva dovuto apportare grosse modifiche.
Insomma, i Gesuiti rubavano un talento alla scuderia del Re Sole ma allo stesso tempo davano lustro all’arte francese in quello che fu il cantiere ecclesiastico più importante della Roma di fine Seicento. E la cosa, conoscendo le mire del monarca assoluto, dovette senz’altro rappacificarlo. Quanto a Legros, tagliava il cordone ombelicale col grande patrocinatore e guadagnava in libertà di manovra e notorietà. La sua scalpitante ambizione trovava sfogo. I Gesuiti gli avevano procurato un atelier a palazzo Farnese. I Domenicani, sotto l’egida del francese Antonin Cloche, lo contendevano ai rivali. Lo accoglieva l’Accademia di San Luca, tempio delle belle arti in orbita vaticana. Anche nel privato le cose andavano a gonfie vele, con giovane moglie conterranea e primogenito. Da buon padre di famiglia e oculato gestore, Legros raggruzzolava e investiva. A Roma come a Parigi.
All’apice della carriera e nel pieno della maturità il nostro fu destinatario di una nuova allettante proposta dai mecenati prediletti. Bisognava dare sembianza a un giovinotto polacco alter ego del Gonzaga: intelligenza acuta, precoce zelo ascetico, gran voglia d’emanciparsi dalla routine nobiliare, invaghimento per i Gesuiti romani. Si chiamava Stanislao Kostka. Si spense a 18 anni, narra l’agiografia sopraffatto da un crudele morbo. Altro novizio altra chiesa: siamo a Sant’Andrea al Quirinale. Paradigma dell’estro berniniano. Destinazione classica di gite urbane da scuola media, immancabilmente in combinazione con la vicinissima San Carlo alle Quattro fontane. Borrominiana. E balenavano derby.
Ci sarò passato centinaia di volte. Avanti e indietro dalla Nomentana verso piazza Venezia e ritorno. Per biblioteche o archivi, musei o caffè. In motorino come in auto. Che a Roma non è la macchina, ma l’(auto)bus. Stavolta mi fermo. Parcheggio. Il motorino non l’auto. Salgo la scalinata d’ingresso. «L’equilibrio» tra architettura, scultura e pittura mira a «suscitare in colui che entra nella chiesa un movimento profondo di affetti spirituali, come nella migliore tradizione della spiritualità ignaziana». Così online[5]. Sarà che ho altro per la testa ma mi vince il basso istinto di tirar dritto verso il banchetto-biglietteria. È sistemato in un andito a destra dell’altare e schiude la strada al vecchio noviziato. Rovisto nei ricordi. Ho l’impressione che il tour di quand’ero scolaretto non prevedesse l’ascesa al dietro le quinte. Ragione in più per addentrarmi.
Legros qui duetta col genius loci. Vuole dar corpo agli ultimi attimi di Stanislao. L’artista allora prende di punta il precedente. Quella beata Ludovica Albertoni scolpita da Gian Lorenzo Bernini per la chiesa di San Francesco a Ripa in Trastevere. La chiamano estasi ma ha tutta l’aria di un’agonia. Agonia estatica taglia corto qualcuno[6]. Col senno scollacciato del XXI secolo si direbbe un orgasmo. Opposti estremismi. La donna è stesa su un materasso, la testa poggiata su cuscini finemente ricamati. Levita il panneggio delle vesti, enfatizza gli spasmi della carne. Il capo è rovesciato. La mano destra contratta sul petto. La sinistra sul ventre. Sapienti giochi prospettici e di luce fanno convergere lo sguardo su di lei, inusualmente coricata sopra l’altare della cappella con tutto il letto e il suo esagerato svolazzar di coltri.
Pare il successo avesse reso Legros incapace di dissimulare la consapevolezza del proprio talento. Difficile il contrario quando celebrità e onori t’investono presto senza abbandonarti. Quando il confronto con un ingombrante padre pigmalione è brillantemente risolto. Quando conquisti, straniero, il sommo palco del mondo. Erede del tuo stesso idolo: scomparso quando eri un adolescente ma onnipresente nelle tracce che giganteggiano attorno a te, e te che ti sforzi per librarti fin lassù. La vitalità chiassosa del mattatore venuto da Napoli si stempera nelle atmosfere tenui del parigino. Se non c’è polemica dottrinale, c’è almeno un compassato realismo che calma i corpi e induce al raccoglimento. A interiorizzare. Muoversi con cautela.
Dentro la camera dell’evento tutto parla d’atmosfere celesti ma a non farci caso si è in compagnia d’un ragazzo e del suo trapasso. In Technicolor. Marmo nero del Belgio, giallo antico, diaspro rosso di Sicilia, alabastro, et cetera. Così Legros fa apparire Kostka qui e ora a grandezza naturale. Non è un unicum quanto a policromia ma resta un’eccentricità da effetto speciale. L’impeto tempestoso della Albertoni si è placato. Se di agonizzanti si tratta, lì era in corso una furibonda lotta per la sopravvivenza. Qua la serena resa all’ineluttabile è compiuta. L’abbandono di gesti e tessuti lo mostra.
Mi avvicino e noto che il bianco delle carni è punteggiato da macchie color malva. Per molto meno Michelangelo diede via un Cristo portacroce che dopo vicissitudini varie è finito in una chiesa di Bassano Romano: tristanzuolo dietro una grata in legno, si gira per nascondere lo sfregio sul volto. E proprio Bernini rifece in fretta e furia un busto di Scipione Borghese per via d’una crepa. Qui l’imperfezione non solo c’è ma mi piace pensare che sia perfino dolosa. Pustole o piaghe? Ma magari no. Macchiette simili a dire il vero spuntano anche sui cuscini che sorreggono il malato. Il dubbio resta e le fonti non assistono.
Ridiscendo nell’aula liturgica e punto verso la curva destra dell’ellisse che mi avvolge. Mi sono documentato. È in quello spazio che Legros avrebbe voluto piazzare la statua. Cioè nella cappella dell’allora beato Stanislao. C’era da completare la decorazione in vista dell’imminente canonizzazione e si dibatteva sul da farsi. Lo scultore immaginò una soluzione simile a quella dell’altare d’Ignazio al Gesù, col quadro che fa su e giù e la statua, normalmente nascosta, che spunta a sorpresa[7]. Sennonché ai Gesuiti l’idea piacque poco. L’uno e gli altri misero per iscritto le rispettive ragioni in una breve ma puntuta tenzone in cui a tratti s’invertono i ruoli: l’artista fa l’esperto di marketing spirituale e i padri spiccano per senso estetico.
Obiettarono che spostare il Kostka dalle camerette avrebbe rovinato la bilanciatissima decorazione della chiesa. Bernini aveva tanto insistito col cardinale committente per mantenerla com’era. Oltretutto, scrissero, si sarebbe perso l’effetto emotivo dell’opera nella stanza «dove tra il chiaro e oscuro […] fa vedere a chi entra come un morto sul cataletto, che multo compunge» – cioè quella vicinanza fisica che sola poteva generare l’empatia altrimenti impossibile con la visione a distanza davanti l’altare in chiesa. E ancora. La statua sarebbe risultata sproporzionata e avrebbe implicato decorazioni costosamente pretestuose: «turabuchi et empitura di cattivo sapore al palato dei periti».
No, replicò Legros: la statua ci sarebbe stata benissimo in cappella. Anzi si poteva metter lì l’originale e fare una copia in gesso per il piano di sopra: «se una concilia divozione, maggiore ne sarà conciliata da due, collocate però in luoghi diversi». Cattolicamente impeccabile. Ma mi permetto di dire la mia, «Monsù Legrò»[8]. O si mette l’originale su alle camerette e un’eventuale copia in cappella o pellegrini e curiosi indugeranno sul primo esemplare. Perché salire le scale per andare a vedere un duplicato, benché posizionato in luogo devozionalmente strategico? Va bene che non siamo nell’era della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte e che una copia ben fatta può valere l’originale, a maggior ragione quando si tratta d’immagini religiose. Però per un intenditore conta tanto il materiale e pure chi lo lavora.
Ma le chiacchere stanno a zero. Ai padroni di casa interessava che il Kostka marmoreo stesse (più o meno) là dov’era spirato, in omaggio a una verosimiglianza in cui s’intrecciavano venerazione e pregio artistico. E poi non dimentichiamo l’effetto inflazione, arguivano i padri: più difficile è l’accesso all’opera, maggiore ne è il valore cultuale. Sì, fa l’altro, ma più facile è la fruizione più gente vedrà l’opera; più grande sarà il successo maggiore la pubblicità. E il volume delle offerte. E la celebrità dell’artista, aggiungo io. Chiaro che dietro la richiesta ci fosse l’ambizione di creare un ambiente capace di competere con quello in cui si sdilinquisce la Albertoni. Tra il creativo che discetta di tattica devozionale ed ecclesiastici che fanno i critici d’arte mi pare che i secondi non avessero granché da guadagnarci, e al limite abbiano preso un abbaglio, mentre il primo ci stesse marciando almeno un po’, destinato, come sappiamo, alla sconfitta.
Correva l’anno 1713. Il capolavoro occultato gli si rivoltava contro come prole ingrata. Mentre la statua collezionava estimatori diventando un’ambita perla nascosta del turismo capitolino, Legros pagava caro l’incaponimento. Finiva l’idillio coi Gesuiti. Iniziava la china discendente. Calcoli biliari minavano la salute. Un’operazione a Parigi e la tentazione frustrata di ristabilirsi là. Il ritorno a Roma. Problemi coi vertici dell’Accademia di San Luca per una bega amministrativa in cui si schierò coraggiosamente dalla parte di colleghi discriminati. Ci guadagnò l’espulsione che completava la sua disgrazia professionale in città. Qualche lavoro ancora, di cui un paio memorabili a Torino grazie all’amico Filippo Juvarra. La morte nel 1719. La vedova, seconda moglie e transalpina pure lei, cercherà invano di far erigere un busto in suo onore in San Luigi dei Francesi. Dove fu sepolto e tuttora riposa.
Quando il duello sul Kostka scavava un fossato tra l’artista e i suoi principali committenti, Legros aveva già immortalato tanto del pantheon gesuita ma non aveva ancora avuto la soddisfazione di veder conclusa la colossale impresa che sorge a pochi metri dall’altare al Gonzaga in Sant’Ignazio[9]. Torno allora sui miei passi. L’indirizzo ce l’ho, la strada la so. Navata destra, transetto destro. Di nuovo al cospetto del santo mantovano. Mi giro a sinistra. Immane monumento funebre a mo’ di fondale. Ospita le salme di papa Gregorio XV e di suo nipote cardinal Ludovico. Erano entrambi Ludovisi, prodotti dell’educazione gesuita. Assai cari alla Compagnia: uno canonizzò Ignazio; l’altro commissionò la costruzione della sua chiesa. Di qui l’iscrizione funeraria che spiega il senso del tandem: Alter Ignatium Aris Alter Aras Ignatio. Chi innalzò Ignazio agli altari, chi altari a Ignazio innalzò.
Mi rigiro verso il Gonzaga, poi di nuovo i Ludovisi.
Le quattro colonne attorcigliate diventano due fusti lisci, rossastri. Una nitida cornice di qua, un berniniano drappeggiare di là, sontuoso e seducente come una barocca stanza dei bottoni. La corona di fiori che plana sulla testa di Luigi ora è un lussuoso baldacchino a proteggere e celebrare il vicario di Cristo, sovrano della cattolicità. Le mani del giovane Gonzaga pudicamente raccolte sul petto, il suo volto serafico, la veste sobria, il delicato aleggiare mutano nel corpo pesante del vecchio papa assiso, il braccio destro retoricamente levato a benedire, i simboli del potere ostentati. L’allegro volteggiar d’angeli e angiolilli, le austere Purezza e Penitenza lasciano il posto a Fama, Religione, Magnificenza, allo stemma di famiglia. I putti che già disdegnavano le glorie secolari qui coccolano l’effigie del cardinal nepote, incarnazione di quel che conta in un’ambiziosa famiglia aristocratica: moltiplicarsi, fare squadra, occupare posizioni di comando.
«Attacca l’asino ’ndo’ vo’ ’r padrone» chioserebbe nonna (di cui sopra).
[1] P. Julien, Pierre Legros. Sculpteur romain, in «Gazette des Beaux-Arts. La Chronique des Arts», 142e année, (mars 2000), pp. 189-214; G. Bissell, Pierre Le Gros 1666-1719, Reading, Si Vede, 1997; R. Enggass, Early eighteenth-century sculpture in Rome, London, Pennsylvania State U.P., 1976, pp. 124-148; S. Baumgarten, Pierre Le Gros artiste romain, Paris, Librairie Ernest Leroux, 1933. Ben fatta è la voce di wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Le_Gros_the_Younger#cite_ref-21.
[2] P. Pecchiai, Il Gesù di Roma, Roma, 1952, p. 183, p. 261.
[3] Ivi, p. 180 ss. (cit. p. 181).
[4] A. de Montaiglon (éd.), Correspondance des Directeurs de l’Académie de France à Rome […], tome 2, 1964-1699, n. 650, La Teulière à M. de Villacerf, surintendant des bâtiments, Rome, 15 novembre 1695, Paris, Charavay Frères, 1888, p. 174. Consultabile online al seguente indirizzo: https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/12727/?offset=#page=175&viewer=picture&o=info&n=0&q=
[5] https://santandrea.gesuiti.it/arte/architettura/
[6] P. Julien, Édifiante souffrance: l’agonie extatique, du Bernin à Pierre Legros, in Ch. Grell – M. Stanič (éds.), Le Bernin et l’Europe. Du baroque triomphant à l’ȃge romantique, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2002, pp. 259-282.
[7] Sul caso Kostka v. E. Levy, Reproduction in the ‘Cultic Era’ of Art: Pierre Legros’s Statue of Stanislas Kostka, in «Representations», n. 58 (Spring 1997), pp. 88-114; la cit.è a p. 109.
[8] Tutte le ultime citazioni sono in F. Haskell, Pierre Legros and a Statue of the Blessed Stanislas Kostka, in «The Burlington Magazine», vol. 97 (Sep. 1955), n. 630, pp. 287-291.
[9] D. Büchel, A. Karsten, Ph. Zitzlsperger, Mit Kunst aus der Krise? Pierre Legros’ Grabmal für Papst Gregor XV. Ludovisi in der römischen Kirche S. Ignazio, in «Margburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft», 29 (2002) pp. 165-198.