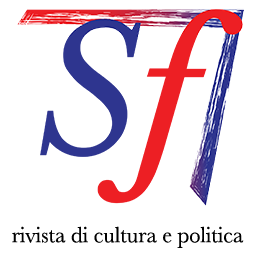La Francia a Roma? Palazzo Farnese, direte voi, San Luigi “des Caravages” o il vicino Centre Saint-Louis. Oppure… piazza di Spagna. I nemici, si sa, per combattersi hanno bisogno di stare vicini. E la stirpe capetingia da troppo tempo troneggiava indisturbata, vedremo come e perché, nei pressi dell’ingresso principale dell’Urbe, piazza del Popolo, per non suscitare i legittimi appetiti degli Asburgo madrileni, nel pieno del loro Siglo de Oro. Negli anni Venti del Seicento, la corona spagnola acquistò dai Monaldeschi il palazzo che da allora avrebbe ospitato la rispettiva legazione presso lo Stato pontificio, ora presso la Santa Sede. Fu un precocissimo caso di palazzo integralmente adibito a residenza permanente di rappresentanza diplomatica[1]. Sul finire del Quattrocento invece, quando ancora le ambasciate erano itineranti, quale miglior modo per ingraziarsi un pontefice che non costruire nella città santa un grosso convento d’innocui frati d’ispirazione francescana con annessa chiesa congruamente decorata?
È quel che iniziò a fare re Carlo VIII comprando terreni allora proprietà di un’altolocata famiglia veneziana. Intermediò quel cardinale Jean de Bilhères che fu il committente della Pietà di Michelangelo per la cappella dei re di Francia, o di Santa Petronilla, nella basilica paleocristiana di San Pietro. Nasceva così la Santissima Trinità del Monte, poi “dei Monti”, cioè del Pincio. Sì perché ottemperando alla virtù tipicamente transalpina della modestia, il complesso sarebbe sorto sulla cima della ripidissima altura, già ambito insediamento per horti e allora adibita a vigneto: al margine settentrionale della città edificata, con invidiabile vista sull’abitato e, soprattutto, una dominante, scenografica posizione di controllo sulla sottostante piazza. Che per qualche tempo sarebbe stata chiamata platea Trinitatis, piazza di Francia o anche piazza sotto la SS. Trinità de’ Monti, prima che l’inquilino iberico conquistasse l’egemonia odonomastica dell’area.
Parigi avrebbe dovuto attendere gli anni in cui nasceva il gemellaggio esclusivo con Roma, cioè i Cinquanta del Novecento, per riottenere un toponimo degno della propria grandeur. Quel lunghissimo Corso Francia (ufficialmente Corso di Francia) che scavalca il Tevere tra Parioli e Tor di Quinto tenendo insieme gli inconciliabili: l’asciuttezza ingegneristica di Pier Luigi Nervi, col suo viadotto da boom economico che sorvola ottimista la sponda meridionale del fiume su piloni di cemento armato; e il trionfalismo littorio di Armando Brasini, che parve un po’ tronfio perfino al Duce e che fu immortalato nel travertino del ponte XXVIII Ottobre [1922, nda] poi ultimato nel dopoguerra e ribattezzato ponte Flaminio.
Ma torniamo intra-muros. Tutto o quasi è noto al turismo di massa intorno alla chiesa della Trinità dei Monti, che contende a quella di San Luigi la palma di regina dei templi cattolici francofoni nella capitale della cristianità. Le chiese “nazionali” di Sant’Ivo dei Bretoni, San Nicola dei Lorenesi e Sant’Andrea dei Borgognoni, retaggio di localismi plurisecolari, completano con meno ambizioni la cinquina romana facente capo alla fondazione dei Pieux Établissements de France à Rome et à Lorette, sotto l’egida dell’ambasciata francese presso la Santa Sede. La fabbrica pinciana è forse la meno indigena del gruppo, singolare prodotto qual è di un Rinascimento nostrano in salsa nord-europea.
Lo suggeriscono i suoi iconici campanili, che nulla hanno a che fare con le facciate controriformiste romane e che sembrano evocare, piuttosto, i torrioni gotici delle cattedrali d’oltralpe[2]. Né le rispettive rotondette sommità possono in qualche modo compensare l’assenza di quell’autentico must della coeva architettura ecclesiastica capitolina: la cupola. Al posto della popputa protuberanza, qui alberga niente meno che uno spigoloso parallelepipedo che ospitò una biblioteca. Oggi vuota, l’ex sala di lettura sovrasta l’area nobile dell’aula liturgica: prova di una passione erudita programmaticamente conciliata con la fede. Torneremo avanti sulla questione. Stupefacente per i cultori di romanità è poi la vista di tracce schiettamente gotiche che fanno bella mostra di sé nel presbiterio e dintorni, lascito di una sperimentazione esotizzante poi anestetizzata da successive classicistiche ristrutturazioni.
L’aula sarebbe viepiù user friendly se un’immane cancellata in ferro battuto non ne dividesse in due l’unica navata all’altezza della terza cappella, retaggio del genius loci cenobitico e dell’originario bisogno di separatezza dal mondo. La cancellata è chiusa quando non c’è messa; aperta in caso di funzione, con cartelli che invitano il passante a unirsi alla liturgia ma che vietano di bearsi delle sublimi arti generosamente elargite tutt’attorno. Un paradosso del culto che ha almeno risparmiato la fruibilità della cappella, la seconda a sinistra, dove si conserva la concitata, potente “Deposizione” di Daniele Ricciarelli alias Daniele da Volterra (1545 ca.). Un estro meno fausto lo ispirerà di lì a una ventina d’anni quando nel clima retrivo del Concilio di Trento avrebbe ceduto al diktat censorio contro i nudi del suo maestro Michelangelo nella cappella Sistina. Braghettone sarà ingenerosamente etichettato, ma i suoi mutandoni, risparmiati non a caso nel restauro filologico di fine Novecento, potrebbero esser stati decisivi per salvare dai bigotti uno dei capolavori della pittura universale.
Che dire, invece, dell’attiguo convento? Fino a qualche tempo fa ben poco, perché gli accessi erano consentiti con modalità un po’ farraginose. Da circa un anno a questa parte la Communauté de l’Emmanuel, gruppo laicale che ha sostituito le Fraternità monastiche di Gerusalemme nella gestione del complesso, ha approntato un calendario di visite guidate prenotabili via e-mail con qualche giorno di anticipo. Pochissime date ogni mese ma sicure. E a un prezzo ragionevole, data la qualità del sito e del recente gigantesco restauro che gli ha restituito il lustro offuscato, oltre che la competenza di chi accompagna i gruppi nell’esplorazione[3].
Per un convento che si apre al pubblico arricchendo l’ormai sterminata offerta del moderno Grand Tour a Roma, è una storia di arcaica semplicità a preparare la strada alle grandi scenografie del Pincio. Fu, infatti, nelle remote lande della Calabria cosentina che vide la luce, all’inizio del Quattrocento, una delle figure centrali della spiritualità europea del secolo: San Francesco di Paola. È a lui che dobbiamo la fondazione dell’ordine dei Minimi, che fu primo assegnatario del convento e artefice delle sue fortune. Come giunsero i Minimi – cioè gli ultimi, i servi della charitas – a occupare l’altura da cui si dominava l’Urbe? Del poverello d’Assisi, Francesco di Paola portava il nome, l’umiltà, il filantropismo e la capacità di far miracoli. Tutte virtù che nella Francia dei re taumaturghi non passarono inosservate agli occhi di Luigi XI, magari buono per sanare i propri sudditi ma lui stesso preda di un misterioso, incurabile male.
Restio a lasciare la terra avita, Francesco dovette sottostare al volere del papa Sisto IV, a sua volta interpellato dal re di Francia affinché intercedesse per lui. La venuta del pio guaritore a Tours, dove allora risiedeva la corte reale, non salvò il sovrano dalla morte ma almeno lo fece spegnere in grazia di dio. Di lì, iniziò per Francesco una fortunatissima carriera francese. Così fortunata da farlo restare oltralpe a guidare spiritualmente il figlio del suo defunto protettore, asceso al trono col nome di Carlo VIII. Quando Francesco morì nel 1507, i suoi Minimi erano ormai entrati saldamente nelle grazie dei pontefici, tanto che il loro fondatore sarà canonizzato da Leone X già nel 1519, e del nuovo sovrano di Francia, che si mosse, appunto, per concedere loro un degno radicamento capitolino. Eremiti per vocazione, gli “innocui frati” di cui sopra s’insediavano solennemente nella Città; sbocciati da un misticismo plebeo e mediterraneo, erano di casa presso una corte reale adagiata sulle sponde dell’algida Loira; malvisti dalle autorità aragonesi nel Regno di Napoli per il loro pauperismo al limite della disobbedienza civile, si affermavano ormai come garanti spirituali di una superpotenza continentale in ascesa.
Non solo, ma i presìdi si estendevano all’area germanofona, dove avrebbe contribuito alla loro rinomanza una birra oggi di comune reperibilità sugli scaffali dei nostri supermercati: la Paulaner. E raggiunsero anche la Spagna. Per contendere a Parigi il monopolio del culto, re Filippo IV finanziò l’aereo altare della chiesa intitolata al santo paolano a Roma. Il blasone reale sorvola lo “scenografico panneggio di stucco” pensato da Giovanni Antonio De Rossi e realizzato negli anni in cui si lavorava alla cattedra di San Pietro del suo maestro Bernini[4]. In sagrestia, però, è tempo di revanche. In una delle lunette che l’adornano, Anna di Bretagna, consorte di Carlo VIII, porge il figlio neonato a Francesco, tutore spirituale della felice gravidanza. Nel duello tra Madrid e Parigi, finiranno per spuntarla i Calabresi: è questa la loro chiesa “nazionale” in città.
L’area su cui sorge Trinità dei Monti è ancora proprietà francese, dunque tecnicamente extraterritoriale. Il che fa del Pincio un distretto transalpino d’ampiezza ragguardevole, considerando anche l’adiacente Villa Medici che dall’inizio dell’Ottocento ospita l’arcinota Académie. Lo stesso convento, estromessi i frati ai tempi dell’occupazione napoleonica, ne entrò a far parte per breve tempo. Nessun bisogno di carte d’identità in quest’enclave e men che meno di passaporti, beninteso, ma l’imprinting patriottico dei cugini salta all’occhio fin dal primo ambiente conventuale: il chiostro.
Tra le serene arcate rinascimentali, appaiono dapprima le grandi lunette sotto il soffitto, in cui si dispiega il racconto pittorico della vita di Francesco: dai primordi ai prodigi fino alla strepitosa ascesa politico-religiosa, il tutto corredato da lunghe didascalie in latino[5]. Fin qui, nulla di sorprendente. Inconsueti, invece, e piuttosto incombenti, i medaglioni secenteschi coi re di Francia dalle origini al regnante Luigi XIV, che occhieggiano seriosi dalla volta. Tra le altre, spicca l’effigie aureolata di Sanctus Carolus Magnus. Ebbene sì. Carlo Magno è santo, di nicchia ma santo. Tale fu proclamato dall’antipapa Pasquale III nel XII secolo.
Tra fede, arte e politica, si fanno largo le porte dell’antica “speziaria”. Aperta nel Seicento e accessibile alla clientela esterna, rivaleggiò con quella di Santa Maria della Scala nel fornire agli avventori, come recita ancora l’insegna affrescata, “theriaca” e “mithridato”, cioè, con grecismo meno arcano, farmaci. La prima locuzione, oggi evolutasi in “teriaca” o “triaca”, indica un antidoto tendenzialmente universale il cui mito ha attraversato le epoche e le civiltà spegnendosi solo agli albori della chimica farmaceutica moderna; mentre l’altra ne fu a lungo l’immancabile complemento, a imperitura memoria di quel Mitridate inconsapevole pioniere di certa terapia allergologica d’avanguardia. Peccato che della protofarmacia pinciana non si sia salvato pressoché nulla, a differenza di quella trasteverina: conservata a puntino e musealizzata.
Tra i frequentatori dell’illustre laboratorio medicinale vi fu padre Charles Plumier, eminente botanico vissuto tra la seconda metà del Seicento e il primo Settecento. Fu proprio a Trinità dei Monti che Plumier si convertì alla botanica dopo un’iniziale infatuazione per le scienze matematiche[6]. I suoi studi sulle piante tropicali potrebbero aver influenzato la rara decorazione naturalistica di una delle celle, non aperta ai visitatori ma sì ad alcuni addetti ai lavori[7]. Ulteriore indizio di una tensione spirituale strettamente connessa con la ricerca scientifica, sia teorica che applicata. Difatti i prodotti galenici venduti nel convento erano preparati in loco lavorando le piante medicinali coltivate nell’adiacente verziere, ormai adibito a prato. Dall’orto che fu, si coglie appieno il palinsesto architettonico che tiene insieme chiesa, convento e relativi nuclei costruttivi, giù fino al confine con Villa Medici. E si apprezza il restauro filologico che qua, come altrove, ha riportato i colori della città alle tonalità preunitarie.
Fu dopo l’annessione al Regno d’Italia e la sua promozione a capitale che Roma si tinse d’ocra scuro e rosso pompeiano, secondo il gusto del tempo. All’avvicinarsi del Giubileo del 2000, il centro storico fu teatro di un epocale cantiere con relativa querelle tra anciens (i difensori dei colori sabaudi, ormai storicizzati) e modernes (apparentemente ultra-anciens, ma in realtà paladini delle più recenti e filologiche tecniche di restauro). Tracce dei cromatismi rossastri variegati al grigio smog tanto familiari all’adolescente di fine secolo che ero restano sparuti su qualche facciata, in attesa dei fondi necessari e sufficienti. A Trinità dei Monti si ammira sia il “color dell’aria”, quel grigio-azzurro che fa tanto barocco, sia il bianco-panna simil-travertino. Questo si ottiene lavorando l’intonaco con uno strumento, la gradina, capace di conferirgli la porosità tipica del materiale principe di Roma. Un ottimo espediente quando non si voleva smarrire nobiltà edilizia in assenza dei quattrini normalmente dovuti per ostentarla.
Entrati nel convento, si sale alla cappella della Mater Admirabilis. È uno spazio d’aspetto ottocentesco, aperto alla preghiera e tappezzato di ex-voto. Ad attirarli è un affresco assai venerato dipinto da una studentessa, Pauline Perdrau, che fu allieva della scuola delle suore del Sacro Cuore insediatesi qui nel 1828. In uno stile vicino a quello dei Nazareni, raffigura una Madonna con gli attrezzi per cucire, il capo basso, immersa in uno spazio scandito dalle geometrie del pavimento e dell’architettura circostante, su uno sfondo naturalistico appena abbozzato. Fu poco amato dalla madre superiora, e perciò celato con un telo. Durante una visita al convento, papa Pio IX, incuriosito, chiese e ottenne di svelare il dipinto, che gli parve ammirevole e tale fu detto. Era il 1846. Nel 1854 lo stesso pontefice proclamava il dogma dell’Immacolata concezione. Il monumento celebrativo, la nota colonna, onora l’amica Spagna, posto com’è vicino all’ambasciata il cui balcone fece da palco per il pontefice il giorno dell’inaugurazione. Ancora un derby in campo neutro tra campioni della geopolitica e del culto mariano.
Nei corridoi del primo piano, dove un tempo si affacciavano le stanze dei frati, si schiudono i tesori di maggior pregio. Si comincia con un’anamorfosi. Etimologicamente, il termine sta a indicare la rappresentazione ricostruita, o rinnovata, di un oggetto: è solo al secondo sguardo, e ottemperando a precise condizioni ottiche, che l’immagine si mostra nella sua verità figurativa. Ma è lecito parlare di verità nel regno dell’illusionismo e delle apparenze? Siamo di fronte a un San Francesco di Paola in preghiera, raffigurato a fresco su un’ampia superficie di muro dal pavimento al soffitto, che s’incurva in una volta a botte verso le finestre affacciate sul chiostro. Sul lato a noi prossimo, un albero dal grosso fusto s’inerpica rinsecchito verso l’alto e il centro, allontanandosi sempre più scheggioso e ramificato, per poi ripopolarsi, alle estremità, di qualche fogliolina speranzosa. I colori sono bigi, sobri, ben leggibili grazie al lavoro dei restauratori. La figura del santo è allungata verso il fondo del corridoio ma perfettamente verosimile, proporzionata, rassicurante anche se sfuggente.
Mossi da un’urgenza estetica o da una scintilla di devozione, o forse solo dall’invito rituale della nostra guida, camminiamo lungo il corridoio cercando di restituire compattezza a quanto vediamo. È tutt’altro quel che troviamo. La figura dell’eremita calabro resta lì ma si tramuta, lascia posto ad altro da sé. Le stesse masse di colore paiono ricomporsi senza spostarsi. L’e-turista da souvenir fai da te perde il senso d’onnipotenza: difficile inscatolare in uno smartphone una metamorfosi che vuole osservazione analogica, un lento andirivieni, accorti sondaggi. Quel che prima era uomo e santo ora è natura spaziosa, quieta. Precisamente un paesaggio del Mezzogiorno punteggiato di figurine in lontananza che recitano una storia.
La storia racconta di quando Francesco, bisognoso di approdare in Sicilia per estendere a quelle terre la sua predicazione, chiese a un barcaiolo di traghettarlo sull’altra sponda dello stretto di Messina. Alla venale risposta del nauta, che si disse disponibile ma solo dietro compenso, Francesco replicò adagiando il suo mantello sull’acqua e adoperandolo come galleggiante. Il resto del tessuto, gonfiato dal vento, fece da vela fino a che il nostro non giunse sano e salvo a destinazione.
Un apologo sulla carità, dunque. Ma anche un virtuosismo pittorico che celebra il sacro e trasuda scienza. Nella prima metà del Seicento furono attivi alla Trinità dei Monti due padri Minimi francesi, Emmanuel Maignan e Jean-François Niceron. Maestri della prospettiva, i due sperimentarono a Roma le conseguenze creative di un’estetica del dubbio che sa di cartesianesimo. Attraverso rappresentazioni prospettiche polisemiche, significati religiosi e scientifici diversi dall’apparenza emergevano all’osservatore solo dopo attento esame. La verità si svelava una volta che il dubbio era dissolto e la ragione vinceva l’illusione. Delle acrobazie artistiche dei due si è pensato per lungo tempo che si fosse conservata solo la più recente, il San Francesco di Paola con relativo miracolo dipinta da Maignan. In anni recenti, è stata rinvenuta anche quella di Niceron: San Giovanni evangelista nell’isola di Patmo che scrive l’Apocalisse sive un generico paesaggio[8]. I colori sono un po’ sbiaditi e meno scioccante è il percorso anamorfico. Una civetta, o un gufo chissà, scruta da un lato ammonendoci che la vista è strumento potentissimo a saperlo usare bene come un predatore notturno.
Un cartiglio sopra le spalle di San Giovanni recita “citra dolum fallimur”, un motto non nuovo nel mondo dei periti della prospettiva[9]. Si potrebbe intendere: senza dolo siamo ingannati, nel senso che l’illusione visuale è fatta senza malizia, senza intento sviante o corruttore. Ma anche: siamo vittime d’inganno a prescindere dal (al di qua, prima del) gioco prospettico dell’affresco. Traduzione, la prima, che accentua il lato moralizzante, pedagogico, dell’operazione; mentre la seconda enfatizzerebbe l’illusorietà intrinseca della nostra percezione sensibile, il bisogno di attenzione, acutezza, studio per poterla rendere solida e consapevole. D’altronde a pochi metri da qui si entrava nella ricca biblioteca. Graffiate su un muro tra una finestra e l’altra, rozze vignette da soldatesca di occupazione ci riportano a prosaici pensieri.
Nel corridoio tra un’anamorfosi e l’altra, si resta irretiti dal vertiginoso turbinare di un orologio solare catottrico che ci avvolge per tutta la lunghezza dello spazio architettonico. Non siamo solo noi contemporanei a trovare ostica l’intricata ragnatela: una discreta legenda, a saperla decifrare, vorrebbe offrire aiuto ai consultatori dell’opera. Pure stavolta c’entra padre Maignan, che si esercitò in analoghe imprese sia qui a Trinità dei Monti che a palazzo Spada. Altro scrigno d’invenzioni prospettiche d’autore, dove l’ingegno del frate si affina e s’intreccia con gli spunti di Borromini&co.[10].
Tutte queste sofisticatezze figurative, ben nascoste nel silente convento, sembrano discretamente preludere alle rutilanti fantasmagorie che avrebbero abbagliato Roma e il mondo nei decenni a venire, spalancando al cielo volte di chiese e soffitti di palazzi, plasmando piazze, librando angeli, angioletti e putti, colorando di solidi marmi e volubili giochi pirotecnici per effimero diletto di papi, signori e popolino. Non sorprende, alla fin fine, che il padre gesuita Andrea Pozzo ci meravigli anche qua, come nelle principali fortezze cittadine della Societas Iesu, con le sue coraggiose soluzioni spaziali[11].
Siamo nel refettorio, dove i Minimi consumavano i loro frugali pasti obbedendo a una rigorosissima quaresima perpetua. Fu per far risaltare quest’austerità gastronomica che gli affreschi della salle à manger sanno di palazzo nobiliare? Siamo alle Nozze di Cana, in pieno XVII secolo. A Pozzo, scienziato prestato alla pittura, le figure umane dovevano apparire un noioso orpello dentro ardite quadrature. Lasciò le forme antropomorfe agli assistenti, dedicandosi alle architetture dell’immane loggiato che apre squarci in trompe-l’œil tutt’attorno. Ci guarda sornione da sotto la tribuna dei musici quel Re Sole che tanto brigò affinché il convento reale desse lustro a Parigi[12]. A completare l’apparato decorativo ci sono i soggetti tipici del sito, compreso, sul soffitto, un Carlo Magno santificato in medaglione monocromo verde. Ma ormai non ci sorprende più.
La visita è finita. Scoprirò per conto mio, tra libri e web, gli angoli a oggi inaccessibili. Curiosissima è la settecentesca stanza detta del Pappagallo, o delle Rovine, già cella del committente padre Le Sueur. Sono un colpo di genio di piranesiana ispirazione gli affreschi di Charles-Louis Clérisseau, a simulare un tempio diruto e pittoresco. La decorazione era accompagnata da un arredo, oggi assente, che, pasticciando antico, falso antico e vero nuovo, assecondava l’aspetto capricciosamente decadente del vano. Appollaiato su una trave superstite, vigila un volatile esotico col suo sgargiante piumaggio.
Usciamo. Scivola ancheggiando tra la folla la sontuosa scalinata. Ci vollero decenni di negoziazioni e una congiuntura geopolitica propizia perché il lascito di un generoso mecenate d’oltralpe, e legato francese a Roma, consentisse la costruzione di quest’inno giubilare alla chiesa soprastante (la scala è tripartita ad hoc), ai Minimi (omaggiati da apposita targa) e ovviamente alla corona francese (i gigli, certo, ma circolò un progetto con statua equestre di Luigi XIV). E c’è chi ciancia di Spanish Steps! La fontana della Barcaccia fu invece un fendente di Urbano VIII. Ai rivali stranieri, il sovrano locale voleva ricordare che la piazza era comunque un brano della sua capitale[13]. I simboli araldici dei Barberini e i fori a bocca di cannone campeggiano, in effetti, con una certa assertività.
Decano per ragioni anagrafiche ma giovane per presenza nella scenografia è l’obelisco sallustiano. Venne innalzato a fine Settecento per volontà di Pio VI, pochi mesi prima della rivoluzione che tante pene gli avrebbe arrecato. L’erezione del monumento arricchiva le connessioni urbanistiche tra capisaldi della città cristiana enfatizzate fin dai tempi di Sisto IV. Fu ancora un punto a favore della primazia papale sull’area? Chiaro. Ma aguzzate la vista. Non notate qualcosa sotto la croce e lo stemma di famiglia del pontefice, lassù in cima? Ha l’aspetto di un fiore déjà vu.
1 A. Anselmi, Il Palazzo dell’ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, Roma, De Luca, 2001.
[2] Sebbene gli architetti fossero italiani e qualche ascendenza autoctona il progetto ce l’abbia: F. Bilancia, La facciata della Trinità dei Monti: dal progetto di Annibale Lippi al completamento di Antonio Ilarione, in C. Di Matteo, S. Roberto (a cura di), Trinità dei Monti, Ricerche, nuove letture, restauri, Roma, De Luca – Editori d’arte, 2016, pp. 115-136.
[3] Tengo a ringraziare la nostra guida, Francesca Barberini, per avermi consentito di registrarla durante il tour. Per informazioni sulle visite date un’occhiata qui: https://trinitadeimonti.net/it/chiesa/visite/
[4] L’Italia. Roma, vol. 2, TCI-La biblioteca di Repubblica, 2004, p. 312. Dell’interno della chiesa, attualmente chiusa per restauro, si possono vedere varie immagini in un programma di RAI5 consultabile al seguente indirizzo web: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-98709585-23b8-4da0-a50d-405348b542df.html
[5] M. Moretti, La decorazione cinquecentesca del chiostro della Trinità dei Monti. Arte e politica nei rapporti diplomatici tra la Francia e la Roma di Gregorio XIII, in Trinità dei Monti, Ricerche, nuove letture, restauri cit., pp. 177-194.
[6] L.-H. Vignaud, Des mathématiques à la botanique. La conversion scientifique du P. Charles Plumier durant son séjour à Rome (1676-1681), in «Mélanges de l’École française de Rome», 117 (2005), n.1, pp. 131-157.
[7] G. Fratini, F. Moriconi, Il convento della Trinità dei Monti: le fasi della costruzione e le successive modificazioni, dalla fondazione dei Minimi al Novecento (ivi, pp. 77-136).
[8] G. Fratini, F. Moriconi, Datazione e attribuzione dell’anamorfosi di San Giovanni a Pathmos presso il Convento della Trinità dei Monti a Roma, in «Mélanges de l’École française de Rome», 122 (2010), n.1, pp. 123-135; A. De Rosa, Jean-François Niceron. Prospettiva, catottrica e magia artificiale, Roma, Aracne, 2013.
[9] Compare, ad esempio, sul frontespizio di un importante trattato sulla prospettiva scritto dal matematico marchigiano Guidobaldo del Monte e pubblicato nel 1600 (http://digitale.beic.it/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=BEIC&docId=39bei_digitool188740). Si veda in proposito: S. Marconi, Guidobaldo del Monte e Piero della Francesca. Raffronti prospettici, in A. Becchi, D. Bertoloni Meli, E. Gamba (eds.), Guidobaldo del Monte (1545-1607). Theory and Practice of the Mathematical Disciplines from Urbino to Europe, Berlin, Edition Open Access – Max Planck Institute for the History of Science under Creative Commons, 2013.
[10] C. Càndito, Corrispondenze ottico-prospettiche tra le opere di Maignan e di Borromini a palazzo Spada, in «Mélanges de l’École française de Rome», 117 (2005), n.1, pp. 73-89.
[11] Pozzo lavorò soprattutto nel refettorio ma offrì probabilmente la sua consulenza per la decorazione della biblioteca, conchiusa da un soffitto ligneo dipinto (San Francesco di Paola che contempla la Trinità, e i quattro Dottori della Chiesa): L. Salviucci Insolera, Andrea Pozzo e collaboratori nel convento di Trinità dei Monti, in Trinità dei Monti, Ricerche, nuove letture, restauri cit., pp. 201-209; C. Bigari, Il ciclo pittorico di Andrea Pozzo nel Refettorio della Trinità dei Monti: la tecnica esecutiva e le vicende costruttive (ivi, pp. 210-212).
[12] E.C. Napolitano, Erasing Papal Presence. The Minims and the Marking of French Territory on the Pincio, 1662-1670 (ivi, pp. 44-56).
[13] La fontana mirava probabilmente a festeggiare la resa della fortezza ugonotta di La Rochelle nel 1628: M.A. Kuntz, Celebrating the Surrender of La Rochelle in Rome. Urban VIII, the French National Churches, and Bernini’s Barcaccia Fountain (ivi, pp. 57-67). Sulle dispute giurisdizionali intorno al quartiere dell’ambasciata spagnola, v. Anselmi, Il Palazzo dell’ambasciata di Spagna cit., pp. 171-189.