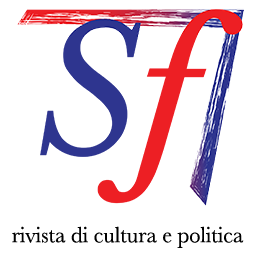Ma che è lui per Ecuba e Ecuba per lui, perché egli ne debba piangere?
Shakespeare, Amleto, Atto II scena 2.
[…] perché ha scoperto, in età matura, che di ciò di cui non si può teorizzare, si deve narrare.
Eco, Risvolto di copertina de Il nome della rosa, settembre 1980
Cronaca postuma di un’ossessione. Mi perdonerà il lettore se le cose che sto per dire avranno qualcosa di personale. Di solito, e per buone ragioni, ciò che è personale viene escluso dalla comunicazione accademica perché ritenuto responsabile di contaminare l’ordine altrimenti obbiettivo degli argomenti. In questo caso, però, in una occasione come questa, mi sento autorizzato a uscire dalla convenzione, e vorrei proporre alcune considerazioni che, mentre le pronuncio, vorrebbero anche essere un dialogo con Claudio De Boni.
Di solito, quando s’intende celebrare la memoria di qualcuno, anche solo per omaggiarne la personalità, si fa riferimento alle passioni che lo hanno catturato e animato. Alle passioni si associa quel tanto di magnanimità e di generosità che ci si aspetta facciano parte di una personalità cui tributare la nostra attenzione. Chi mi ha preceduto ha seguito questa strada, mostrando come Claudio De Boni sia stato uno studioso magnanimo e generoso nei suoi interessi e nella sua produzione scientifica più influente. Io, oggi, vorrei provare a seguire una strada diversa. Più che di una passione di Claudio De Boni, come uomo e come autore di testi generosi, vorrei parlare di una sua ossessione, il romanzo poliziesco, convinto che seguendo questa strada sia possibile trovare anche uno dei segreti della sua scrittura, oltre che un indizio o una serie di indizi del suo metodo.
Sul fatto che si tratti di una ossessione, o addirittura di una piccola patologia, non ci sono molti dubbi. Già il poeta inglese Wynston Hugh Auden scriveva sull’Harpers Magazine nel 1948 come si tratti di «una droga al pari del tabacco o dell’alcol», un’ossessione che si traduce in forme di dipendenza collegate innanzitutto all’«intensità del desiderio». Tale dipendenza può avere effetti non nocivi se opera sul soggetto che ne è affetto come un dispositivo capace di intrattenimento. Il romanzo poliziesco, in questo senso, si configura come un gioco, con delle regole da seguire, la cui trasgressione comporta metamorfosi continue e cambi di paradigma. S. S. Van Dine nel settembre del 1928 su «The American Magazine» aveva elencato le venti regole per un crimine d’autore. Il segreto del successo tra molti intellettuali di un genere che ha i caratteri di un gioco suscettibile di ripetizioni può essere vista qui: il romanzo poliziesco nella misura in cui esplicita le sue regole, per poi magari trasgredirle, si configura come un esercizio ludico, esplicito e ripetibile, in cui la mente del lettore è sollecitata a mettersi alla prova. De Boni non è un caso isolato. Soffrivamo della stessa dipendenza, oltre che di altre cose. Il filosofo Ludwig Wittgenstein – forse il più celebre tra gli ossessionati dal genere – riteneva, ad esempio, che la mancanza di pretese intellettuali dei racconti d’indagine fosse il segreto della loro seduzione intelligente. Come gioco intellettuale su scala ridotta spingono il lettore a esercitarsi in un genere d’investigazione che è comparabile a una ricerca metafisica su piccola scala. È noto, in proposito, il giudizio tranchant che Wittgenstein formula sul valore comparativo tra le riviste che raccoglievano antologicamente racconti polizieschi (in particolare sulle riviste pulp di Street & Smith di New York) e la rivista accademica «Mind»: a più riprese sembra che Wittgenstein ritenga la lettura dei racconti polizieschi più proficua per la mente della lettura dell’organo ufficiale della filosofia inglese. In una lettera del 30 ottobre 1945 all’allievo Norman Malcom, che lo riforniva dagli Stati Uniti dei numeri della rivista altrimenti introvabili in Europa, Wittgenstein scrive: «Sto già pregustando il nutrimento mentale che mi hai promesso; quando leggo le vostre riviste, mi domando spesso come qualcuno riesca a leggere “Mind”, così insulsa e fallimentare, invece di divertirsi con i gialli di Street & Smith. Ma ognuno ha i suoi gusti». Come si concilia, però, questa mancanza di pretese capace di nutrimento intellettuale con l’idea che intendo proporvi? Ora – la domanda è più che lecita – in che modo si può parlare del romanzo poliziesco come di una forma che può insegnarci qualcosa sulla scrittura di De Boni, e più in generale sulla scrittura della storia?
Un paradigma indiziario per lo storico? La risposta più ovvia ci potrebbe indirizzare a un’ipotesi avanzata molti anni fa da uno storico italiano di primissimo rango. Presentato per la prima volta nel corso di un seminario all’Università di Bologna nell’anno accademico 1977-78, poi pubblicato a due riprese in un saggio intitolato Spie. Radici di un paradigma indiziario nel 1979, il «paradigma indiziario» elaborato da Carlo Ginzburg rifletterebbe una rivoluzione scientifica nel campo delle scienze umane a cavallo tra Otto e Novecento i cui testimoni sarebbero Sherlock Holmes, Sigmund Freud e il teorico dell’attribuzione in campo artistico Giovanni Morelli. Il segno di tale paradigma sarebbe quello di essere fondato sulla conoscenza tramite indizi – gli indizi polizieschi di Holmes, i sintomi di Freud, i dettagli stilistici che permettevano a Morelli di attribuire un’opera a un autore – contro un paradigma con pretese sistematiche e totalizzanti che aveva dominato nei decenni precedenti. Ginzburg scriveva che le radici del paradigma indiziario potevano essere trovate in un antesignano del metodo attributivo di Morelli, il medico senese del XVII secolo Giulio Mancini, interessatosi tra l’altro alla grafologia, non tanto per le sue caratteristiche psicologiche, piuttosto per il suo presupposto, ovvero «la diversità, anzi l’inimitabilità delle scritture individuali». L’analisi in parallelo di questi tre modelli permette a Ginzburg d’individuare tutta una serie di tipologie indiziarie di cui Holmes si serve per risolvere i suoi casi e che corrisponderebbero alla logica indiziaria che guida anche i lavori di Freud e Morelli, e che potrebbe essere estesa anche al lavoro dello storico, alla sua passione per i dettagli come fonte inattesa di scoperte e rivelazioni.
Partendo dall’esempio di Morelli, Ginzburg conclude scrivendo:
non bisogna basarsi, come si fa di solito, sui caratteri più appariscenti, e perciò più facilmente imitabili dei quadri […] Bisogna invece esaminare i particolari più trascurabili, e meno influenzati dalle caratteristiche della scuola a cui il pittore apparteneva: i lobi delle orecchie, la forma delle dita delle mani e dei piedi.
Ginzburg ha suggerito che le radici più antiche di questo metodo andassero cercate nella semiotica divinatoria, portando ad esempio il celebre racconto persiano, ripreso da Voltaire nel suo Zadig, in cui i tre figli di Serendippo inferiscono le caratteristiche di un cammello che non hanno visto dalle impronte che ha lasciato dietro di sé:
Il nome di Zadig era diventato talmente simbolico che nel 1880 Thomas Huxley, nel ciclo di conferenze pronunciate per diffondere le scoperte di Darwin, definí «metodo di Zadig» il procedimento che accomunava la storia, l’archeologia, la geologia, l’astronomia fisica e la paleontologia: la capacità, cioè, di fare profezie retrospettive. Discipline come queste, profondamente permeate di diacronia, non potevano non rivolgersi al paradigma indiziario o divinatorio (e Huxley parlava esplicitamente di divinazione volta al passato) scartando il paradigma galileiano. Quando le cause non sono riproducibili, non rimane che inferirle dagli effetti.
Ed è proprio grazie all’investigazione su questi effetti che i singoli indizi posso rivelarsi elementi chiave per operazioni ricostruttive capaci di spiegare storie di formato ben più grande.
La rappresentazione delle vesti svolazzanti nei pittori fiorentini del Quattrocento, i neologismi di Rabelais, la guarigione dei malati di scrofola da parte dei re di Francia e d’Inghilterra sono solo alcuni tra gli esempi del modo in cui indizi minimi sono stati assunti volta a volta come elementi rivelatori di fenomeni più generali: la visione del mondo di una classe sociale, oppure di uno scrittore, oppure di una società intera.
È indubbio che lo stesso Ginzburg in quanto storico abbia saputo valorizzare come nessun altro questa logica della scoperta storica a partire dai dettagli apparentemente insignificanti. Ma come hanno mostrato studi che in parallelo venivano portati avanti da altri studiosi (ad esempio da parte dei Sebeok, di Umberto Eco, del filosofo Hintikka) la logica della scoperta che sta dietro a Sherlock Holmes prevedeva l’impiego di una strategia di ragionamento, riferibile al modello dell’induzione, o secondo alcuni dell’abduzione (nelle parole imprecise di Holmes, deduzione), che consiste nel produrre inferenze ipotetiche su concatenazioni di fatti o dati. Il metodo di Holmes corrisponderebbe cioè a un metodo logico di costruire inferenze di tipo filosofico (si fa di solito il nome di Peirce) capaci, sulla base di tipologie indiziarie che si ripetono, di risolvere il mistero che sta al cuore del racconto. Non per niente Conan Doyle, insieme ad Agatha Christie e pochi altri, è considerato il più dotato tra gli scrittori di romanzi polizieschi a enigma. Il poliziesco a enigma è quel genere di racconto in cui il colpevole del crimine efferato, di solito un omicidio, viene smascherato a conclusione di un’indagine che dura tutto il tempo della lettura, ad opera di un investigatore che figura come l’unico ad aver capito cosa è successo. Ogni indagine, in questa trama, è un enigma logico. Ogni investigazione porta a una scoperta. Ogni crimine non ha che una e una sola spiegazione logica.
Vorrei subito dire che quando suggerivo che il racconto poliziesco potesse figurare come un modello per decifrare alcuni segreti della scrittura di Claudio De Boni non pensavo a questo genere di narrazione. Non pensavo a Holmes (che non amava particolarmente), e non pensavo a quel paradigma indiziario che opera scoperte attraverso i dettagli più minuti. E non pensavo certamente alla logica abduttiva di Peirce, né alla logica di nessun altro tipo.
L’utopia di Maigret. Se avessimo chiesto a Claudio De Boni, probabilmente avrebbe detto che si trattava di un metodo troppo filosofico per i suoi gusti. A dire la verità è un’accusa che ha sempre mosso anche a me, alle cose che studiavo, alle cose che scrivevo. Seguendo questa strada, quando ci si occupa di storia si rischia di dare troppo valore all’intelligenza e alla razionalità, con effetti di compiacimento per il soggetto pensante che sfuggono alla complessità del reale. La storia non sopporta tutta questa lucidità di procedure e d’intenti. Si tratta, forse, di un limite che vale anche per il sottogenere del poliziesco: non è difficile, infatti, scovare in queste storie a enigma in cui il protagonista, l’investigatore, capisce tutto e alla fine punisce il colpevole, un carattere compensativo e rassicurante che lascia troppo poco spazio alla realtà.
Chi conosceva De Boni sa che la sua preferenza non andava verso questo sottogenere del genere poliziesco, ovvero il romanzo a enigma. Claudio De Boni ha sempre preferito i romanzi polizieschi d’investigazione, quelli che in Francia si chiamano noir e nei paesi anglosassoni, a partire dal modello originario americano, si chiamano hard boiled. Da Georges Simenon a Henning Mankell, passando per i classici di questo sottogenere, De Boni ha sempre preferito figure di investigatori che nel corso delle loro indagini si trovano immischiati in una trama di realtà più complessa e stratificata. Questo sottogenere investigativo del genere giallo ha costituito una rivoluzione del paradigma del romanzo poliziesco: i suoi caratteri fondamentali sono la completa mancanza di certezze, il configurarsi di verità parziali sempre rimesse in discussione, una rappresentazione fallibilista se non fallimentare della conoscenza (con la figura dell’investigatore che non manca a sua volta di dover fare i conti coi propri fallimenti), una continua sovrapposizione delle cause che generano equivoci ed errori, infine una concezione non lineare dell’indagine, vista come un filo intrecciato e intricato, piuttosto che come una catena logicamente ricostruibile. Chiunque abbia letto un romanzo di Raymond Chandler, o di Dashiel Hammet oppure, per venire ai giorni nostri, di Henning Mankell, sa di cosa sto parlando. Nessuna fiducia nel fatto che segni e dettagli possano condurre alla verità, piuttosto una dose caotica e densa di realtà che inquina sempre il percorso investigativo, e lo rende opaco fino all’invisibilità. Il tutto, poi, trasportato dai salotti, dai castelli e dai vagoni lussuosi delle ambientazioni tipiche dei polizieschi a enigma, alla strada, ai vicoli, agli appartamenti normali e, persino, ai luoghi di lavoro.
Claudio De Boni ha sempre dimostrato una preferenza per figure di investigatori cupi e problematici, lontani mille miglia dalla clinica analiticità di Holmes. Spesso poliziotti, antieroi per antonomasia, scopritori talvolta controvoglia della miseria e della meschinità umana.
Se si cercano tracce di una forma narrativa che lo ha ispirato bisogna guardare in questa direzione. E se ci si rivolge da questa parte non si passa troppo tempo prima di scovare uno dei sui preferiti, se non il preferito: il commissario Maigret, protagonista di un ciclo sterminato di romanzi e racconti (75 romanzi e 28 racconti) dello scrittore belga Georges Simenon.
Il fatto che per Jules Maigret molto spesso le prove morali siano più importanti delle prove materiali è testimonianza del fatto che il suo genere d’indagini non segue la traccia lineare della raccolta d’indizi. Gli indizi psicologici sono sfumati e problematici per definizione, seguono la linea tortuosa delle motivazioni umane, le fratture delle loro contraddizioni. I romanzi di Maigret sono «questioni di atmosfera», come dichiara ne Il cane giallo. Nel romanzo Maigret e l’osteria dei due soldi Simenon distingue programmaticamente due fasi nelle indagini:
In primo luogo, la presa di contatto del poliziotto con un’atmosfera nuova, con persone delle quali alla vigilia non aveva mai sentito parlare, con un piccolo mondo sconvolto da un dramma […] Bisogna saper fiutare la pista. Si annaspa senza un punto d’appoggio, spesso senza un punto di partenza.
Se Holmes per iniziare l’indagine ha bisogno di un appiglio certo in un dato come primo anello della catena deduttiva, Maigret – che una volta ha detto «Niente conclusioni affrettate! E soprattutto niente deduzioni!» – non cerca neppure indizi, cerca «piuttosto di impregnarsi di un ambiente». Le sue investigazioni sono fatte di impressioni non ben definibili.
Il secondo momento dell’indagine è segnato da un’improvvisa illuminazione.
All’improvviso, ecco un capo della matassa e comincia la seconda fase. L’inchiesta è in corso. L’ingranaggio è in moto. Ogni passo, ogni movimento provoca una nuova rivelazione e quasi sempre il ritmo accelerante dell’inchiesta sfocia in una conclusione brutale.
Sebbene si possa anche in questi casi parlare di abduzione, si tratta di un’abduzione che genera un salto logico. Come in Padre Brown o in Philip Marlowe. Anche grazie a questi momenti di riflessività esplicitata, il commissario Maigret è più di un personaggio: è diventato presto un universo finzionale a se stante e un modo narrativo specifico. Nel suo mondo compare una dimensione dell’esistenza non professionale (la famiglia, la sua vita) che ne caratterizza a pieno titolo la problematicità di eroe incompleto. Maigret diventa il vettore di valori e di opzioni, il luogo di esercizio di significative contraddizioni, di rovesciamenti di segni e tracce esistenziali. Le sue inchieste così spesso deragliano o s’inceppano, così che la storia poliziesca torna storia vissuta, esistenziale. Non solo, Maigret diventa lo specchio di una rappresentazione sociale molto tipizzata che non si offre solamente come scena di sfondo per la storia, ma ne costituisce molto spesso il cuore della trama. Per Simenon non solo le classi sociali esistono; esse costituiscono perfino dati rassicuranti della realtà, e Maigret è costantemente impegnato a decifrare i segni dell’appartenenza dei personaggi. Il male e i crimini del mondo simenoniano vengono sempre dalla separazione endemica tra le classi. Di più, un crimine è ciò che mostra la frattura fra queste come fatale. Il dramma emerge sempre sulla soglia di questa frattura. Si può certo sostenere che la scena sociale che si presenta nei romanzi è sempre semplificata: la società appare come il campo di una polarizzazione schematica e tipizzata, ma è con buone ragioni che Simenon è stato indicato come un attento analista sociale. Più in generale è il genere a vantare questo merito. È ad esempio questo, avrebbe probabilmente suggerito De Boni, uno dei segreti del successo recente dei romanzi svedesi svedesi d’investigazione, a partire dal modello di Maj Sjöwall e Per Walhöö, e del loro detective Martin Beck.
Con Maigret il carattere artificiale della finzione drammatica diventa esplicito e si configura chiaramente come un gioco. Simenon gioca con le regole del gioco, dando vita a un gioco nel gioco.
Si prendano ad esempio le sei regole fondamentali del romanzo ad enigma e si osservi come risultino alterate nella trama simenoniana. Le regole potrebbero essere queste:
- C’è un crimine e c’è un colpevole
- Un detective è incaricato di condurre l’inchiesta
- Il detective rimane all’esterno del dramma
- Il detective conduce l’inchiesta
- Il detective smaschera il colpevole e lo consegna alla giustizia
- Il detective è innocente
Inversione della regola in Maigret:
- Non c’è un crimine e non c’è un colpevole
- Il detective non è incaricato di condurre l’inchiesta
- Il detective non rimane all’esterno del dramma ma vi rimane coinvolto
- Il detective non conduce l’inchiesta
- Il detective smaschera il colpevole e non lo consegna alla giustizia
- Il detective non è innocente
Il segreto del racconto poliziesco di seconda generazione sta tutto in questa capacità di sporcare la rappresentazione della realtà con elementi spuri. Si tratta di un «effetto di realtà» a volte consapevole, ovvero esplicitato coi mezzi intellettuali necessari, a volte implicito, frutto dell’intuizione dell’autore; in ogni caso si tratta di un effetto con cui bisogna fare i conti. Come scriveva Siegfried Krakauer in un precocissimo, e fondamentale, studio degli anni Venti del Novecento sul Romanzo poliziesco
Al romanzo poliziesco non interessa affatto riprodurre in forma naturalistica la realtà della cosiddetta civilizzazione, anzi, esso mira fin dal principio a mostrare il carattere intellettualistico di questa realtà ponendo il processo civilizzatore di fronte a uno specchio deformante in cui si riflette la caricatura irrigidita della sua cattiva sostanza.
Che si tratti di Maigret, di Marlowe o di Pepe Carvalho, di Mikael Blomkvist o di Lizbeth Salander, il segreto del romanzo poliziesco, a mio avviso, sta tutto in questa capacità di costruire deformazioni plausibili, e talvolta arrabbiate, del reale.
Passeggiate nella contrada di Ecuba: la teoria narrata come un’indagine. Mi rendo conto di essermi portato molto lontano da dove siamo partiti. Spero però che alcuni elementi si siano fatti più chiari, e che quella matrice nascosta nel romanzo poliziesco che ho suggerito possa svelarci qualche segreto della scrittura di storico di Claudio De Boni sia diventata un po’ più evidente.
A quanto ne so De Boni non ha mai scritto un giallo, né un noir, né in generale un poliziesco. Né – sempre che io sappia – ha mai tentato un’interpretazione del genere letterario che continuasse la lunga tradizione di interpretazioni nobili di un genere popolare (da Krakauer a Wittgenstein a Bloch, fino a Ginzburg o Eco). Non ha mai ceduto a quella tentazione diffusa di rendere filosofico il genere (come ha fatto un allievo piuttosto maldestro di Wittgenstein). Le linee della forma narrativa del poliziesco, soprattutto del poliziesco di seconda generazione, sembrano, però, costituire nella sua prospettiva un banco di prova per sondare la capacità di raccontare anche altri generi di storia. Si prendano solo ad esempio le sei regole rovesciate che vi ho proposto sopra, e provate a mettere lo storico alle prese con la sua ricerca al posto dell’investigatore, come se si trattasse di un gioco a sua volta, magari iniziando dalla seconda.
- Lo storico non ha un mandato obbligatorio per condurre l’inchiesta
- Lo storico non rimane all’esterno del dramma raccontato ma vi rimane coinvolto
- Non è lo storico che conduce l’inchiesta
- Lo storico descrive il suo oggetto di ricerca ma non lo consegna alla giustizia (storica)
- Lo storico non è mai innocente
Messe così sembrano poco più di una boutade. Se le prendessimo sul serio, andrebbero a comporre un decalogo degli errori e degli orrori che lo storico non dovrebbe mai commettere pena la perdita di credibilità e attenzione da parte del lettore (o della comunità scientifica). Eppure, per quanto sbilenche, esse possono anche indicare un modello originale e fecondo di scrittura partecipata che mostra come sia possibile raccontare delle storie da cui non scompare mai un certo effetto disturbante e opacizzante della realtà. La prima regola rovesciata: non c’è un crimine e non c’è un colpevole, potrebbe valere come idea del fatto che non c’è una storia obbligatoria o obbligata che va raccontata, e che non ci sono protagonisti necessari di un racconto che deve valere per tutti.
Se ora, come esercizio finale, tornate a leggervi i libri di De Boni, anche quelli più aulici, quelli dedicati alle utopie, oppure quelli dedicati ai grandi razionalisti francesi del settecento, vi accorgerete rapidamente che quest’effetto di realtà, una certa non linearità dell’investigazione, il configurarsi di verità parziali sempre rimesse in discussione anche quando si presentano come austeri catechismi politici, una rappresentazione fallibilista della conoscenza, una continua sovrapposizione delle cause che generano gli eventi e le trasformazioni, fanno tutti parte del repertorio di una scrittura che non ha mai abbandonato l’intenzione dichiarata di chiarezza intrattenitiva.
La sua perplessità per la deduzione speculativa, tipica di certa filosofia, e per le concatenazioni logiche, non si è mai tradotta, infatti, in forme di empirismo sciatto – come a volte accade nelle scienze sociali contemporanee – anzi, nei suoi lavori migliori essa dà vita a una narrazione che non segue storie obbligate o ufficiali, ma sa, piuttosto, incunearsi nei meandri non scontati della ricostruzione storica – come i migliori detective del genere –, insegue tracce dimenticate o trascurate (magari quelle ritenute meno rilevanti dal canone) attribuendo loro il valore ambivalente di costruzioni efficaci della realtà.
In particolare, però, penso agli ultimi due libri da lui pubblicati (quello sulla religione dell’umanità positivista e quello sugli anarchici francesi), la cui trama a più riprese può essere paragonata a un racconto di suspence in cui non è mai importante scoprire la verità, magari collezionando prove (se non altro perché non c’è nessuna verità da scoprire), piuttosto inseguire le tortuosità creative dell’intelletto umano nelle sue metamorfosi molteplici e imprevedibili (si tratti di positivisti o di anarchici). Forse la storia del pensiero andrebbe scritta sempre così. Non lo so. Non ne sono sicuro, ma certo i libri di De Boni il dubbio me lo fanno venire. Di sicuro, questa domanda è una delle eredità più ricche che ci ha lasciato.
I l filosofo tedesco Ernst Bloch, in una conferenza sul romanzo poliziesco, poi divenuta saggio, tenuta presso l’Università di Tubinga nel 1960, ha detto che quando ci si muove in un territorio cognitivo in cui si dà rilievo alle cose apparentemente meno importanti si entra nella contrada di Ecuba. Il riferimento è ovviamente al noto personaggio shakespeareano dell’Amleto. La contrada di Ecuba è «l’ambito di ciò di cui parrebbe ci si potrebbe tranquillamente disinteressare». Molto spesso, sbagliando. Mi piace pensare che Claudio De Boni sia stato un frequentatore di questa contrada, e che anzi l’abbia saputa attraversare come pochi altri, magari passeggiando come piaceva a lui.