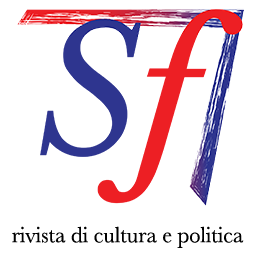Avrei voluto conoscere meglio Claudio De Boni. La nostra era una frequentazione di tipo professionale ed episodico, legata com’era all’incontrarsi in occasione di convegni, seminari e simili; ma negli ultimi anni questa frequentazione si era consolidata, per via del reciproco interesse per le nostre ricerche e per il fatto che entrambi mettevamo al centro del nostro lavoro la Francia dell’Ottocento. Gli ultimi tre libri pubblicati da Claudio – che aveva intensificato, se possibile, la sua attività scientifica dopo il pensionamento – sono state per me altrettante occasioni di confronto con lui: avendo molto apprezzato l’originalità del suo volume sulla fortuna internazionale di Comte (C. De Boni, Storia di un’utopia. La religione dell’Umanità di Comte e la sua circolazione nel mondo, Milano, Mimesis, 2013) ne avevo discusso con Claudio e lo avevo recensito; la pubblicazione del suo libro sugli anarchici francesi dal 1840 al 1914 – su cui tornerò nel seguito – era stata un’ulteriore occasione di scambio di opinioni (C. De Boni, Liberi e uguali. Il pensiero anarchico in Francia dal 1840 al 1914, Milano, Mimesis, 2016). Il terzo volume, l’ultimo pubblicato da De Boni, era un progetto un po’ folle per i nostri tempi di bibliometria anvuriana: la traduzione, con un ampio saggio critico introduttivo, del Catechismo positivista di Comte. Sono stato felice di dargli una mano a realizzarlo, proponendolo in una collana di cui sono membro del comitato editoriale (A. Comte, Il catechismo positivista. Sommaria esposizione della religione universale in undici dialoghi sistematici tra una donna e un prete dell’umanità, a cura e con introduzione di C. De Boni, Roma, Aracne, 2018). Una presentazione del volume a Perugia era già in programma quando la scomparsa di Claudio prima e la pandemia poi ne hanno ritardato, ma non annullato, l’idea.
Poiché in questa sede siamo stati chiamati a trattare un nostro tema di ricerca che avrebbe potuto interessare a Claudio, vorrei concentrare le mie osservazioni sulla storiografia politica riguardante la Seconda repubblica francese. Non c’è dubbio che quel regime rappresentasse un oggetto di interesse comune ad entrambi; fondamentale per lui, data la assoluta centralità in quel contesto del tema del diritto al lavoro, per me la Seconda Repubblica è, da molti anni ormai, quasi un’ossessione, un grande – ma cronologicamente circoscritto – corpus di testi che invita a continui approfondimenti e a sempre nuove ricognizioni, il cui esito più recente ho condensato in un volume pubblicato nel 2020 (F. Proietti, L’invenzione della democrazia. Pensiero politico e istituzioni nella Seconda Repubblica francese (1848-1852), Roma, Aracne, 2020). Avevo avuto modo di fare cenno a Claudio di questo libro ancora in fieri, e lui si era mostrato, con la curiosità intellettuale che lo caratterizzava, interessato a leggerlo una volta pubblicato; il confronto con lui in merito ai risultati di questa ricerca, come ho scritto anche nella premessa a quel volume, mi è molto mancato. In queste brevi note, dunque, cercherò di mettere a confronto le tesi che ho avanzato in quello e in altri lavori con la visione sul 1848 francese che emerge da vari scritti di Claudio. Il titolo che ho scelto per questo mio intervento – che riecheggia, a sua volta, quello di un libro molto bello e importante di Vittore Collina (Id., Le democrazie nella Francia del 1840, Firenze, D’Anna, 1990) – sintetizza la mia proposta interpretativa: vedere nell’effimero regime politico della Seconda repubblica un modello politico, già compiuto, di sistema democratico, sia dal punto di vista del dibattito ideologico, sia da quello del funzionamento istituzionale; compresa l’ambivalenza, consustanziale alla storia del regime democratico dei moderni, tra visioni diverse e contrapposte della democrazia. Nell’affermare questo, la mia interpretazione intende porre in questione quella più classica e prevalente – sin dal 1850, anno di pubblicazione in forma di articoli del testo che nel 1895 Engels, dopo la morte di Marx, intitolerà Lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 –, che vede in quel regime nient’altro che un momento di passaggio tra la Monarchia censitaria e il Secondo Impero, all’insegna della sostanziale continuità del dominio della borghesia capitalista («il regno dei banchieri») e con la complicità decisiva di un socialismo ingenuo e ‘piccolo-borghese’. Un’interpretazione, in sintesi, che mette al centro dell’attenzione il momento sociale rispetto a quello politico, e dunque legge le giornate di guerra civile a Parigi del giugno 1848 come, al tempo stesso, il punto più alto di manifestazione della ‘lotta di classe’ in Francia e il vero momento conclusivo della Seconda Repubblica, ben prima del colpo di Stato del 2 dicembre 1851. Non intendo sostenere che questa interpretazione sia errata o da rifiutare in toto; di certo, però, essa porta ad ignorare completamente le valenze strettamente politiche di quell’esperienza istituzionale, recuperabili solo facendo ricorso a una periodizzazione in parte diversa e più ricca. Credo, ad esempio, che debba essere preso in più seria considerazione, accanto al trauma del giugno 1848, il secondo e altrettanto grave trauma conseguente all’approvazione della riforma elettorale del maggio 1850. Né va sottovalutata la portata epocale, per la storia della democrazia, delle stesse journées de juin: quell’evento fu sconvolgente non solo per i proletari che videro i loro compagni arrestati, fucilati e deportati, ma anche per i tanti sinceri repubblicani (‘moderati’ o meno) che videro folle di operai – ormai pienamente ‘cittadini’, ossia soggetti votanti – scagliarsi contro le istituzioni parlamentari frutto del suffragio universale. Un trauma politico, peraltro, gemello di quello del 31 maggio 1850, quando il parlamento, mutilando il suffragio universale, sembrò rinnegare se stesso e la nascente democrazia rappresentativa, innescando un generalizzato rifiuto della rappresentanza la cui eco, come ho cercato di mostrare nei miei studi più recenti, è ancora ben presente nell’odierno dibattito ideologico sulla democrazia. Ovviamente non intendo attribuirmi meriti di innovazione storiografica che non sono certo solo, né principalmente, miei: dopo gli studi pionieristici di Fabrizio Bracco (cfr. Id., Democrazia diretta e democrazia rappresentativa in Francia 1850-1851, in Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno [secoli XV-XX], vol. II, Maggioli, Rimini, 1983, pp. 579-614), risalenti ai primi anni Ottanta del secolo scorso, nell’ultimo ventennio da più parti si è autorevolmente sottolineata la centralità del ‘momento politico’, variamente inteso, nella parabola della Seconda Repubblica, mettendo in questione implicitamente il paradigma marxiano, se così vogliamo definirlo: penso, ad esempio, alle osservazioni presenti negli studi di Pierre Rosanvallon e Alain Garrigou dei primi anni Duemila (cfr. in particolare P. Rosanvallon, La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris, Gallimard, 2000; A. Garrigou, Histoire sociale du suffrage universel en France. 1848-2000, Paris, Seuil, 2002) e ai contributi più recenti di Olivier Ihl e Samuel Hayat (O. Ihl, Une ingénierie politique. Augustin Cauchy et les élections du 23 avril 1848, in «Genèses», [décembre 2002], n. 49, pp. 4-28; Id., Louis Marie Bosredon et l’entrée dans le suffrage universel. Sociogenèse d’une lithographie en 1848, in «Revue d’histoire du XIXe siècle», [2015], n. 1, pp. 139-163; S. Hayat, Quand la République était révolutionnaire. Citoyenneté et représentation en 1848, Paris, Seuil, 2014), per non nominare che i principali.
Qual era la posizione di Claudio rispetto a questo problema e a questo dibattito storiografico? I primi indizi per arrivare a una possibile risposta si trovano nell’importante antologia da lui curata e relativa alla discussione sul diritto al lavoro nel ’48 francese. Edito nel 2002, quel volume di fatto inaugura una temperie caratterizzata dalla riscoperta della rilevanza ideologica di quei dibattiti (cfr., fra i più interessanti frutti di quella stagione, gli studi di E. Antonetti, Il lavoro tra necessità e diritto. Il dibattito sociale nella Francia tra due rivoluzioni [1830-1848], Milano, FrancoAngeli, 2004 e Th. Bouchet, Un jeudi à l’Assemblée: politiques du discours et droit au travail dans la France de 1848, Montréal, Nota Bene, 2007). Se nell’introduzione di quel libro De Boni, da un lato, aveva l’indubbia lungimiranza di rivalutare i dibattiti svolti in seno alla Commission du Luxembourg (liquidata, viceversa, da Marx con lo sprezzante appellativo di «sinagoga socialista»), dall’altro faceva suoi alcuni motivi (alcuni clichés, mi verrebbe da dire) dell’interpretazione storiografica più ‘classica’. Ad esempio, in quella sede presentava i costituenti del ’48, i cosiddetti ‘repubblicani moderati’, come «riedizione […] della Palude, ma con molto più opportunismo e molto meno attaccamento alla rivoluzione della sua omologa del 1792» (C. De Boni, Introduzione a Il diritto al lavoro nel 1848. Antologia di scritti e discorsi, a cra di C. De Boni, Milano, Mimesis, 2002, p. 26). Va tenuto ben presente, d’altro canto, che l’adesione di Claudio al paradigma storiografico che vede nella Seconda Repubblica essenzialmente la manifestazione di una crisi sociale era funzionale al fatto che il suo interesse di ricerca preminente era la ricostruzione del dibattito sullo stato sociale – oggetto non solo di quello, ma anche di tanti altri suoi fondamentali saggi (mi riferisco in particolare alla vera e propria ‘trilogia’ costituita da C. De Boni, Alla ricerca dello stato sociale. Politica ed economia nel pensiero francese della prima metà dell’Ottocento, Padova, Cedam, 1999; Id., Lo stato sociale nelpensiero politico contemporaneo. L’Ottocento, Firenze, Firenze University Press, 2007; Id., Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento, 2 voll., Firenze, Firenze University Press, 2009) – e per quella via era arrivato a studiare il 1848; non stupisce, quindi, non trovare nel suo testo considerazioni approfondite sulle forme politiche assunte da quel regime.
In altri scritti, tuttavia, De Boni non solo si mostra consapevole della rilevanza della questione politico-istituzionale in Francia all’altezza del 1848, ma solleva il problema (cruciale, secondo me) della relazione tra questo ordine del discorso e quello, a lui più caro, riguardante la ‘questione sociale’. Ne prendo in considerazione due. Il primo è un saggio del 2010, dal titolo Questione sociale e Stato: un conflitto di idee entro il ’48 parigino (in Curtatone e il 1848 toscano, italiano ed europeo: la trasformazione del popolo in nazione, a cura di P.F. Giorgetti, Pisa, ETS, 2010, pp. 209-226). Le promesse tematiche contenute nel titolo sono solo in parte mantenute: infatti De Boni afferma esplicitamente che «per cogliere appieno il senso dell’esplosione parigina del 1848, e delle idee e passioni che stanno alla sua base, occorre […] inserire un terzo elemento [oltre a borghesia e proletariato], vale a dire lo stato» (ivi, p. 210); ma, nello sviluppo del testo, è ancora una volta sul tema del diritto al lavoro e sulla sua discussione nei primi mesi del 1848 che si concentrano le sue osservazioni. Mi ha colpito, rileggendo queste pagine di Claudio, la sua affermazione per cui la famosa frase (la cui paternità va ascritta, pare, a Lamartine) contenuta nel proclama del Governo provvisorio del 18 marzo 1848 in base alla quale, in conseguenza dell’applicazione del suffragio universale, «non ci sono più proletari in Francia» costituirebbe la migliore esemplificazione dell’«astrattezza del pensiero liberale ‘classico’» di cui erano portatori, a suo avviso, i fondatori della Seconda Repubblica (ivi, p. 213). Si tratta di un’opinione che in altri tempi avrei forse sottoscritto anch’io; ora penso, invece, che proprio quella frase – così assurdamente ingenua per le nostre orecchie di viventi nel XXI secolo – vada presa sul serio, e si debba partire proprio da lì per cogliere un nodo profondo dell’intreccio tra questione sociale e questione politica nella Francia del tempo. I proletari erano sempre stati esclusi dal suffragio in quanto proletari, sulla base, cioè, della ben nota logica del voto capacitario; ora, per la prima volta nella storia, questa interdizione era caduta. Per Lamartine, come per altri suoi contemporanei, ciò significava che un discorso pubblico di tipo nuovo, di tipo autenticamente repubblicano e democratico, sulle modalità per regolare, anche legislativamente, un mercato come quello del lavoro, abbandonato al laissez-faire nella fase monarchico-censitaria, poteva ora essere espresso, e trovare una rappresentanza parlamentare a sostenerlo. In altri termini, si respirava nella primavera del 1848, almeno nella capitale, un clima di fiducia nei confronti della democrazia rappresentativa come strumento più idoneo a realizzare il fine ultimo del miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori salariati. Questa illusione tramontò definitivamente non nelle giornate di giugno, ma solo quando, con l’imposizione di una nuova legge elettorale che, di fatto, escludeva dal voto, in modo selettivo, proprio una parte consistente delle masse proletarie, la democrazia parlamentare iniziò ad essere percepita come un governo effettivamente dominato dalla classe borghese e consustanziale ad essa; del tutto inadatto, quindi, a realizzare le promesse politiche e sociali della democrazia. E autori come Rittinghausen proporranno, a quel punto, uno strumento diverso – la legislazione diretta – per realizzare un fine che era sempre il medesimo, ossia la riforma sociale. Per tutte queste ragioni, sono personalmente convinto della necessità di ricostruire congiuntamente, in sede storiografica, il discorso sulla questione sociale e quello sulla questione politica sotto la Seconda Repubblica; un intento che, come detto, Claudio enunciava già, senza però darvi seguito, nel breve saggio qui richiamato.
Un secondo scritto che mostra una evoluzione degna di nota nell’approccio di De Boni allo studio della Seconda Repubblica è il già citato volume del 2016 sul pensiero anarchico in Francia. Qui Claudio dedica un intero capitolo a Joseph Déjacque, un autore assai poco frequentato dalla storiografia, compresa quella sull’anarchismo, e oggetto solo in tempi recenti di una riscoperta in grande stile da parte di una serie di studiosi francesi (cfr. Th. Bouchet-P. Samzun, eds., Libertaire! Essais sur l’écriture, la pensée et la vie de Joseph Déjacque [1821-1865], Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2019) mostrando, ancora una volta, di saper intercettare (o addirittura anticipare) temi di grande attualità storiografica (Per sua stessa ammissione, il suggerimento di dedicarsi allo studio di Déjacque gli era venuto, peraltro, da Fabio Bertini). De Boni, che aveva già trattato brevemente di Déjacque in un suo precedente articolo – Un’utopia anarchica: l’”umanisfera” di Joseph Déjacque, in G. Schiavone-D. Martina (a cura di), L’utopia: alla ricerca del senso della storia. Studi in onore di Cosimo Quarta, Milano, Mimesis, 2015, pp. 341-354 – soffermandosi su questo personaggio mostra attenzione per quella costellazione di autori ‘minori’ che furono centrali non solo nei dibattiti politici della Seconda Repubblica, ma anche negli anni successivi; tra questi, in una posizione forse preminente, quel Moritz Rittinghausen delle cui idee ho cercato di ricostruire qualche anno fa la fortuna internazionale nell’Ottocento (F. Proietti, La législation directe par le peuple di Moritz Rittinghausen: il testo e i contesti della sua diffusione, in M. Rittinghausen, La legislazione diretta del popolo, o la vera democrazia. Testo e contesti, a cura di F. Proietti, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 1-154). Proprio dall’idea di legislazione diretta di Rittinghausen l’esule Déjacque trae ispirazione per una serie di articoli pubblicati nel 1859 nel periodico «Le libertaire», da lui fondato a New York. Questi articoli, che fanno da pendant all’interno dell’opera di Déjacque al progetto di Umanisfero al quale soprattutto si riferisce De Boni, mostrano un acuto interesse, da parte dell’anarchico francese, per la questione tutta politica della migliore organizzazione del processo legislativo (su questo tema cfr. A.-S. Chambost, Une voix étrange et dissonante de la démocratie radicale. Joseph Déjacque et la législation directe, in Libertaire! cit., pp. 199-210).
In conclusione, provo a indicare qualche aspetto di un possibile programma di lavoro riguardo alla Seconda Repubblica che a me sembra abbastanza nuovo e sul quale avrei desiderato poter conoscere il punto di vista di Claudio. Non si tratta, a mio avviso, di volgersi al versante politico del 1848 francese invece che al versante sociale, ma di mettere in luce i molteplici legami che in quel contesto si instaurano tra i due momenti. Senza dimenticare che Rittinghausen, esattamente come faranno più tardi i socialdemocratici tedeschi e svizzeri dietro il suo impulso, ma anche i riformisti statunitensi di fine secolo, non proponeva la sua visione della democrazia referendaria come un sistema perfetto di legislazione né come un fine politico in sé, bensì come strumento – l’unico secondo lui – in grado di tradurre in leggi i progetti di riforma sociale elaborati dai teorici socialisti. Il sistema rappresentativo-parlamentare, a suo giudizio, non avrebbe mai potuto farlo, perché dominato dalla borghesia e consustanziale ad essa. Vale la pena sottolineare come, su questo punto, l’analisi di Rittinghausen e quella coeva di Marx coincidessero, differenziandosi fortemente in merito alla pars construens e ai mezzi da opporre al parlamentarismo borghese: la «vera democrazia» per il primo, la rivoluzione proletaria per il secondo. Su queste compenetrazioni, evidenti a mio avviso, tra elementi ‘strutturali’ e ‘sovrastrutturali’ nel contesto francese di metà Ottocento avrei voluto, soprattutto, confrontarmi con Claudio.